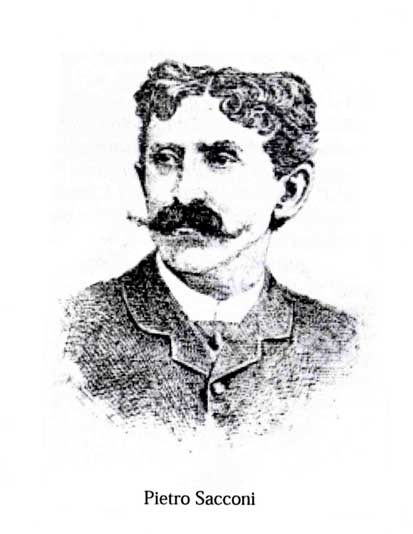|
Pietro Sacconi |
||||||||
|
Manlio Bonati, 14-12-04 |
||||||||
|
Uno dei nostri, purtroppo, dimenticati esploratori è l’emiliano Pietro Sacconi. Nato l’11 febbraio 1839 a Borgonovo Val Tidone (Piacenza), fu un fervido patriota. Prese attivamente parte alla campagna del 1866, nel Trentino, distinguendosi per gli atti di valore; si era arruolato nel 10° Bersaglieri sotto gli ordini del generale Giuseppe Garibaldi. Finita la guerra, sempre vestito con la gloriosa camicia rossa garibaldina e con pochi mezzi di sostentamento, si trasferì ad Alessandria d’Egitto, che presto abbandonò per impugnare nuovamente, sempre come volontario, le armi a Candia, che si era sollevata contro la dominazione ottomana. Passò poi al servizio della Compagnia Khediviale di Navigazione, indi a quella per lo scavo del Canale di Suez, poi ancora agente di una casa commerciale di Gedda. Mai fisso in un luogo, tornò in Egitto per ripartire improvvisamente per Massaua, dove si incamminò per il paese dei Bogos. Qui il padre Giovanni Stella aveva impiantato la Colonia Italo-Africana dello Sciotel. Questa coraggiosa iniziativa fallì per l’ostilità dell’esploratore svizzero Werner Munzinger, rappresentante degli interessi dell’Egitto in quella regione. Così il Sacconi ritornò ai lavori del Canale, ma sempre per breve tempo. Infatti, anima inquieta e piena d’iniziativa, nel 1869 si mise in viaggio per Aden e Zeila con un carico di fucili da barattare. Il governatore di Zeila era l’Emiro Abu-Baker, noto per l’ostilità che usava verso gli stranieri (nel 1876, all’epoca della grande spedizione italiana guidata da Orazio Antinori, Giovanni Chiarini e Sebastiano Martini Bernardi, i nostri connazionali vennero trattati malamente). Prima di partire per Zeila il piacentino si era procurato formali assicurazioni sulla disponibilità dell’emiro a scambiare i fucili con prodotti di quei paesi. Ma Abu-Baker, avuti i fucili, procrastinava, con evidente malafede, da un mese all’altro la consegna delle merci al Sacconi. Questi, perduta la pazienza, si presentò presso il potente, che si trovava contornato dai suoi fedeli, esigendo ad alta voce che stesse ai patti. L’Emiro lo minacciò di farlo decapitare. Il Sacconi stanco e furibondo, trasse di tasca un revolver che puntò sulla fronte dell’uomo, giurando che gli avrebbe fracassato il cranio se non gli avesse immediatamente reso giustizia. L’energica azione dell’italiano, di garibaldina memoria, ebbe l’effetto desiderato: Abu-Baker pagò in merci le armi che aveva trattenuto. Successivamente Sacconi visitò i mercati di Taggiurra (o Tagiura), Bulhar, Berbera, Harar. Studiò la lingua somala, i climi dell’interno, le abitudini degli abitanti e i loro prodotti. Ritornato ad Aden, riprese a visitare la costa arabica. Proprio in quel periodo ebbe l’opportunità di aiutare l’equipaggio della nave italiana Vedetta, naufragata nei pressi di Gedda. Poco dopo compì un viaggio in Abissinia e al suo ritorno si fermò a visitare Assab, primo piccolo possedimento italiano in terra africana. Divenne subito un entusiasta sostenitore di questa occupazione coloniale.
Con gli scambi commerciali il Sacconi aveva raccolto un modesto gruzzolo, allorché il 6 settembre 1872 (data indelebile nella sua memoria), non lontano da Lasgori, fu assalito e fatto prigioniero dai Somali della tribù dei Vorsingelli. Gli indigeni lo legarono a un grosso albero, mettendosi tra loro a disquisire sul modo più idoneo di ammazzarlo. Il Sacconi, uomo di molto coraggio, di sangue freddo, pratico della lingua, non si perse d’animo e, chiamati i capi, disse loro: “ Voi mi avete rubato quanto io avevo indosso, alcune centinaia di talleri; ma quella non è tutta la mia fortuna. Laggiù nella rada di Lasgori tengo un sambuc (barca) custodito dai miei servi fedeli, che rinchiude una somma ben superiore. Se mi date la vita, io vi prometto di consegnarvi tutto quel denaro”. I Somali accettarono la proposta, soldi contro la vita. Il Sacconi si salvò. Perdette, però, il frutto di sette anni di risparmi. Negli anni successivi il Nostro avventuroso esploratore, avendo di nuovo realizzato un discreto capitale, si diede al commercio dei bachi da seta, navigando più volte per il Giappone. Sopravvenuta una crisi in questo settore, si trapiantò nuovamente in Africa, dove fatalmente era attratto dai pericoli e dai ricchi traffici. Infatti il 27 giugno 1882 partiva da Napoli col Birmania per riprendere la via del Mar Rosso e del golfo di Aden. Giuntovi in compagnia del fratello Gaetano, lo attraversava per recarsi in Harar, importante stazione commerciale del Corno d’Africa dove da qualche anno si era insediato il governo egiziano già padrone della costa. I fratelli Sacconi avviarono, per incarico della milanese Società d’Esplorazione Commerciale in Africa, un giro d’affari di una certa importanza, essendo Harar il punto di ritrovo di molte carovane somale, galla e di altre lontane popolazioni. Pochi mesi dopo, considerato che il commercio di pelli, di caffé e di altri generi andava bene, i due fratelli fecero venire dall’Italia i loro nipoti Vincenzo e Giuseppe Guasconi. In Harar, dove ormai risiedevano i quattro nostri connazionali, già da tempo si era stabilito il francese Jean-Arthur Rimbaud (1854-1891), il poeta maledetto, che visse dieci anni in Africa occupandosi di commerci, non escluso - forse - quello degli schiavi, ed esplorazioni (in compagnia del marsigliese Jules Borelli). Di notevole interesse è quanto il Sacconi scrisse sui provvedimenti igienici usati dagli egiziani. “della inconcepibile incuria del Governo di Harrar, a provvedere d’inferriate le fogne che portan fuori le immondizie della città, accampando esso che le materie solide e il fango non potrebbero aver libero sfogo, e preferendo così che per quelle aperture le jene entrino a centinaia in città e divorino i poveri vajolosi. Dietro le mie insistenti preghiere, Nady Bascia, prima di partire per l’Egitto, ordinò si pensasse al modo di distruggere quelle fiere. Giorni sono, infatti, il mamur (prefetto di polizia) m’invitò gentilmente a una partita di caccia in città per quella stessa notte. Alle quattro del mattino, chiuse le porte della città, ci collocammo su delle alture presso gli sbocchi e sul far del giorno cominciò la fucilata. – I cittadini mezzi spaventati, montano sui tetti, credendo di essere assaliti dagli abissini.- Questa gente, già da più anni s’è fatta in capo che un giorno o l’altro Harar cadrà in mano di re Johannes. Alle sei il fuoco era cessato, e alle sette, sulla piazza del Sugh (mercato), 14 grossissime jene rappresentavano le spoglie opime della notturna nostra impresa”. In Harar c’erano cinque porte d’ingresso, guardate dai cinquemila soldati egiziani del presidio, ciò nonostante di notte, in particolare nella stagione delle piogge, entravano le iene, attratte dall’odore dei molti ammalati di vaiolo, che attendevano la morte abbandonati a se stessi nelle vie della città. Un giorno il Sacconi mise in fuga una di queste belve che aveva in parte sbranato un malato, poi deceduto in seguito alle ferite. Nel giugno 1883 si propagò la voce che Menelik, re dello Scioa, stava facendo in zona un’azione di saccheggio. Il terrore si sparse per Harar. Pietro Sacconi, Rimbaud, il greco Costantino Rigos e pochi altri compagni decisero di andare di persona a vedere com’era la situazione, incerta per le notizie discordanti che erano riusciti a raccogliere. Il 13 si misero in sella, arrivando presto al lago Aramaio (Alemaia), che fotografarono. Poi giunsero al lago Ahdelli e a una bellissima prateria con villaggi “ cinti da siepi d’europhobia “. Dopo altre ore di cavallo, entrarono nella vallata degli Abodo Galla, con campi di durra meravigliosi e popolosi villaggi, poco benevoli nei confronti degli stranieri. “Come di consueto, noi siamo i primi a dir loro nogoja (buon giorno) aman (amici); alcuni di questi sono restii a rispondere al nostro saluto, altri lo ricambiano di buon animo e da ciò prendiamo norma a impugnare o meno la nostra rivoltella. Questa pratica vien giustificata dal contegno ringhioso di molti fra gl’indigeni, contegno del resto naturale dal fatto che noi siamo i primi europei che vedono. Ad ogni modo vuole prudenza che si mostri loro nessuna volontà di molestarli, come pure estrema fidanza nella nostra forza e sull’armi nostre”.
Si accamparono presso una tribù Galla, dopo averli con fatica persuasi delle loro buone intenzioni. “Appena posto piede a terra siamo circondati da una folla affamata più di noi: sono profughi dei paesi saccheggiati dal generale di Menelik”. Gli europei si fecero raccontare dal monarca Galla, Oriò Càrì, sulla guerra di Menelik contro gli Ittu e gli Assabot Galla. Il giorno dopo ritornarono di buon trotto ad Harar per riferire i risultati della missione. Durante questa breve esplorazione e in quelle che l’avevano preceduta, Sacconi prese nota e descrisse dal punto di vista geografico nuovi fiumi, laghi e tribù che prima non figuravano in nessuna carta dell’Africa. E’ in quei giorni che decise di intraprendere una spedizione per l’Ogaden, il Paradiso dei Somali. In data 7 luglio 1883 indirizzò una lettera al capitano Manfredo Camperio, direttore de L’Esploratore, giornale di viaggi e geografia commerciale, organo ufficiale della Società d’Esplorazione Commerciale in Africa. Pietro Sacconi aveva appunto fondato una fattoria e casa di commercio per incarico di questa società di Milano, di cui era socio corrispondente. Nella citata lettera spiegava che il giorno dopo avrebbe varcato “le frontiere del temuto e misterioso Ogaden, e così saranno squarcite le tenebre in cui è involta questa selvaggia regione. Ignoro se sia il destino o la fatalità che mi spinge sempre ad aprire nuovi commerci coi somali, benché non possa lodarmi di loro, giacché la data del 6 settembre 1872 non potrò mai dimenticarla (avendo perso con loro 7 anni di economie e stenti), ma sono spinto verso questo feroce e intelligente popolo perché scorgo in loro volontà e costanza nel trattar affari e non alieni ad accostarsi alla civiltà europea. Non nascondo le difficoltà che dovrò superare per inoltrarmi in quel paese; spero di riuscire. (…) Agli studiosi prometto poco in causa della mia scarsa cultura, qualche raro esemplare di pianta o d’insetto, qualche cattiva descrizione di usi e costumi; ma la mia mente sarà rivolta tutta agli scambi e ai commerci di quei luoghi. Porto meco una buona provvigione di cotonate quasi tutte delle Indie, e una buona scorta di servi tutti stranieri gli uni agli altri per non essere tradito come nel 1872, a questo modo credo che in caso di combattimento cercheranno di difendere la loro vita. Ho un persiano, un indiano, un arabo cairino, un sudanese, un danakil, un harrarino scrivano, due somali issa, e il mio fedele Jassin somalo della famosa tribù dei Vorsingelli, proprio di quelli che mi presero a Lasgori nell’anno 1872”. Le precauzioni prese nella formazione della carovana mostrano in lui il provetto esploratore, ma i Somali che gli si erano mostrati amici gli prepararono un’imboscata, nei pressi del villaggio chiamato Kora Nagott, e lo uccisero assieme a quattro uomini della spedizione, impadronendosi delle sue mercanzie e di tutto ciò che possedeva. Un mortale colpo di coltello sul fianco gli precluse per sempre la strada per l’esplorazione del fiume Uebi Scebeli. Seguiamo il resoconto sull’eccidio dall’inchiesta egiziana desunta dall’interrogatorio del suo domestico Jassin, pubblicata nel 1883 ne L’Esploratore: “Il 12 agosto il signor Sacconi coricossi sotto la tenda, di cui aveva sollevato gli orli. Il cuoco Haggi-Scidi se ne stava fuori, vicino al fuoco. Jassin trovavasi presso al fuoco. La calma pareva essersi fatta tutt’all’ingiro e la gente della carovana s’addormentò. Tutto a un tratto sbucano da una vicina casa cinque uomini armati di lunghi coltelli e scavalcano la piccola siepe. Non un grido d’allarme. Tre di costoro si gettano su i tre servi addormentati sul limitare della tenda e li ammazzano, spiccando loro il capo dal busto. Gli altri due strappando o sollevando la tela entrano nella tenda e uno d’essi ferisce alla testa il signor Sacconi, producendogli larga ferita. Sbalordito egli grida. Che fate, che fate? E si lancia fuori della tenda tirando due colpi di rivoltella che non colpiscono nessuno. Uno degli assassini con un colpo di sciabola gli spacca netta la mano che teneva la rivoltella, mentre un altro gli immerge nel fianco il suo coltello. Il povero Sacconi cadeva morto”. Jassin cercò invano di salvare almeno gli appunti di viaggio scritti dall’esploratore, che invece il Fakì (giudice locale) Lusuf Sceir gettò alle fiamme. In una lettera del 15 luglio da Baoloh al fratello Gaetano, il Nostro scriveva che i nativi diffidavano dell’uomo bianco, primo che vedevano, avendo il sospetto che fosse una spia turca in avanscoperta. Specificava pure che il suo viaggio aveva due scopi ben precisi: “il commerciale e il geografico, che non può andare disgiunto dal primo se si vuole attivare commerci in un paese inesplorato”. Da Bhomba il 25 luglio annotava: “questi selvaggi sono d’una diffidenza tale che a stento potei conoscere le località di loro dimora. Per poi sapere i nomi dei monti, promontori, torrenti, dovetti sempre usare dei sotterfugi. Se mi vedono scrivere, mi giudicano una spia turca, che sta annotando le particolarità del paese, onde facilitare un’invasione dei loro nemici, altri invece mi reputano un seik (santo). Fui costretto a rimandare i cani in Harrar perché li credevano bestie impure, mentre le jene fanno strage dei loro armenti e ovini Non volli sottomettermi, come è uso, al taglio dei mustacchi e a vestire in arabo, e dichiaro anzi francamente la mia qualità di cristiano e italiano, - sono un problema per gli uni, un kafir (infedele) per gli altri. – Di giorno, mentre son desto, non corro nessun pericolo, perché mi temono, in causa della rivoltella e il fucile; ma di notte, quando dormo, la cosa è differente ed è il momento pericoloso per me”. In un'altra lettera si augurava “che fra tre o quattro giorni al più la bandiera italiana sventolerà per la prima volta nell’ignoto Ogaden, il paradiso di queste contrade interne africane. (…) So che vado incontro a gravi difficoltà e pericoli, ma il pensiero che lavoro per il nostro interesse, che è collegato in questo primo tentativo commerciale nel ricco Ogaden con la gloria e l’interesse della nostra cara patria, mi fa noncurante di ogni critica. Da oggi incomincio la missione che mi imposi volontariamente. Spero di poter riuscire a sormontare tutti i pericoli che mi sovrastano”. Conscio di ciò che poteva succedergli, con spirito garibaldino, proseguì per quella strada fatale che più volte fu il capolinea di tanti nostri italiani, che lasciarono le loro ossa a biancheggiare sotto il cocente sole africano.
Bibliografia: L’Esploratore, diretto da Manfredo Camperio, Milano, Alfredo Brigola & C., annate 1883 e 1884; Ministero delle Colonie – Ufficio Studi e Propaganda (il testo è di Anonimo ma in realtà di Cesare Cesari), Voyageurs Italiens en Afrique, Roma, Sindacato Italiano Arti Grafiche, 1931; Carlo Zaghi, Le origini della Colonia Eritrea, Bologna, Licinio Cappelli Editore, 1934; Cesare Cesari, Orme d’Italia in Africa, Roma, Unione Editoriale d’Italia, 1938. |
||||||||