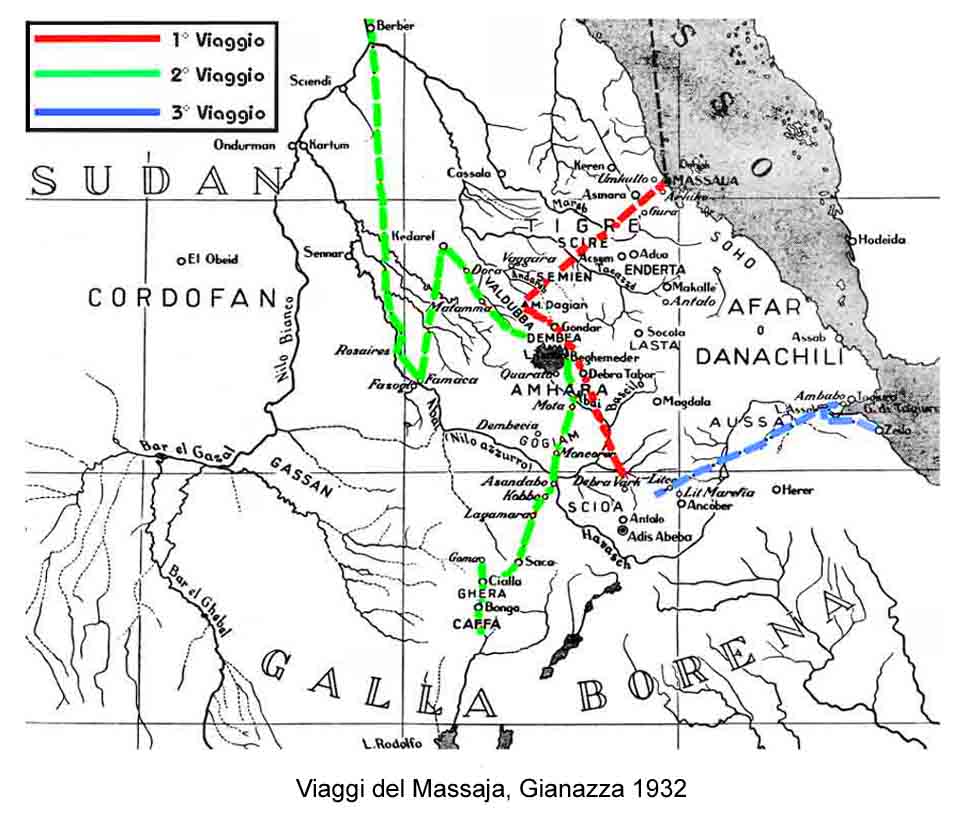Il 28 ottobre
giungeva a Massaua, dove il 26 successivo incontrava
Giustino De Jacobis, Prefetto Apostolico dell’Abissinia,
ed assieme mossero verso l’interno del Paese l’8 dicembre.
In Etiopia
Monsignor Massaja rimase per 35 anni e la sua attività
missionaria viene oggi suddivisa in tre periodi:
1)
Il periodo di penetrazione:
va dall’imbarco a Civitavecchia fino allo sbarco a Massaua
dove si trattenne a lungo. Perlustrò i litorali del Mar
Rosso e del Golfo Arabico nel vano tentativo di trovare
una via, i mezzi ed i lasciapassare che lo facessero
giungere nelle terre dei Galla, nel centro dell’Etiopia.
Il 1849 lo trovò sempre fermo a Massaua dove consacrò
vescovo il lazzarista Giustino De Jacobis. Poi,
osteggiato dal metropolita Abuna Salama II fu costretto
nel 1850 a tornare in Europa a riorganizzare la sua
missione.
2) La missione galla propriamente detta.
Le amicizie coltivate prima di imbarcarsi per l’Africa lo
aiutarono a trovare fondi e salvacondotti indispensabili
per raggiungere il territorio dei Galla in Etiopia in
veste di missionario cattolico. Ripartì per l’Africa nel
novembre del 1852 e questa volta raggiunse prima l’Ennarea
dove fondò la sua prima missione (1854) e poi il Kaffa.
Anche qui fondò un’altra missione (1855); un’altra ancora
a Lagamara-Gimma nel 1859 e nel 1862 a Gudrù, in una
specie di esilio decretatogli dal re Abba Gomol. Decise
quindi di rientrare in Europa a reperire fondi, ma Teodoro
II lo trattenne lasciandolo partire solo l’anno
successivo. Si recò in Francia dove fondò nel 1866 a
Marsiglia il collegio S. Michele per l’educazione dei
giovani galla e pubblicò la prima grammatica ed il primo
catechismo in quella lingua. Per la sua missione trovò
aiuti in denaro dall’imperatrice Eugenia e dal consorte
Napoleone III.
|
Foto di Alberto Vascon |
|
 |
|
Il
ciglione di Assandabò, sul Nilo Azzurro, la prima
missione del Massaja. La valle del Nilo qui è
profonda 1.400 metri. |
3) La missione scioana.
Mentre attraversava lo Scioa nel 1868 per raggiungere
nuovamente le sue missioni nel sud dell’Etiopia, venne
catturato da Menelik II che lo obbligò a restare come
consigliere reale. Non si perse d’animo, ma fondò missioni
anche in quella regione: importante quella di Finfinnì,
elevata nel 1886 a capitale dell’Etiopia con il nome di
Addis Abeba.
E’ in questo
periodo che diede prova di grande diplomazia, appoggiando
e realizzando nel 1872 l’ambasciata del re dello Scioa che
venne ricevuta a Napoli da Vittorio Emanuele II e la
Spedizione Geografica Italiana in Etiopia. Queste due
imprese gli valsero prima la nomina a Grand’Ufficiale
dell’Ordine di San Maurizio e Lazzaro e poi, nel 1979, la
nomina a plenipotenziario del “Trattato di amicizia fra
S.M. il re d’Italia e S.M. il re dello Scioa”.
Nel 1879 Iohannes
IV lo esiliò, e Massaja dovette, durante la stagione delle
piogge, raggiungere a tappe estenuanti Suakim, dove
giunse un anno dopo nel 1880. ll viaggio fu tanto
disastroso che Massaja fu più volte sul punto di morire
tanto che i suoi collaboratori gli allestirono una bara,
che lui usò come letto e come lettiga. Giunse a Suakim in
brutte condizioni, ma riuscì ad imbarcarsi per Gerusalemme
dove decise di rinunziare al Vicariato Apostolico dei
Galla.
L’attività
missionaria del Massaja fu quanto mai intensa: ebbe come
base l’obiettivo costante dalla formazione della gioventù,
spingendola al sacerdozio, abbinando alla evangelizzazione
un autentica promozione umana, combattendo di persona
contro le malattie endemiche, in particolare contro il
vaiolo: veniva chiamato dagli etiopici “Padre del Fantatà
(vaiolo)”. Lottò senza riserve per l’abolizione della
schiavitù, e si trovò sempre in prima linea facendosi
promotore di centri assistenziali, di iniziative per
prevenire la carestia, la siccità, cercando in tutti i
modi di pacificare le tribù in lotta, di promuovere lo
sviluppo agricolo. Visse sempre di poco, tutto quello che
riusciva ad avere lo donava ai poveri, col coraggio di
dire sempre quello che pensava ai potenti, senza alcuna
paura di ritorsioni, ma al contempo con una prudenza
oculatissima che gli assicurarono una grande autorità
morale.
4)
Periodo postmissionario.
Il 2 agosto 1881 il suo mecenate Leone XIII lo consacrò
Arcivescovo di Stauropoli e il 12 novembre 1884 lo elevò
cardinale. Lo stesso pontefice lo invitò a scrivere le sue
memorie che lo fecero conoscere al mondo. Esse
rappresentano ancora oggi un ottimo punto per la
comprensione dell’Abissinia dell’800. Nel cinquecentesco
convento dei cappuccini di Frascati curò ed archiviò la
grande raccolta di materiale raccolto (armi,
suppellettili, costumi ed oggettistica la più varia).
Ispirò numerosissimi missionari e influì mirabilmente su
molti fondatori di congregazioni religiose. Morì a San
Giorgio a Cremano (Napoli) il 6 agosto 1889.
Nel 1892 gli venne
eretto un monumento a Frascati, opera dello scultore
Cesare Aurelj, collocato nella Chiesa dei Cappuccini, dove
nel 1909 venne inaugurato il suo Museo. Nel 1914
iniziarono i processi per la sua beatificazione. Lo Stato
italiano gli dedicò nel 1952 un francobollo da 25 lire,
realizzato dall’artista Mario Colombati.
L’opera del
Massaja fu ripresa, agli inizi del ‘900, dai Missionari
della Consolata di Torino.