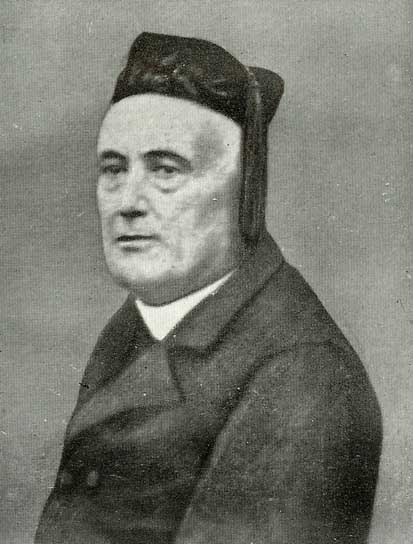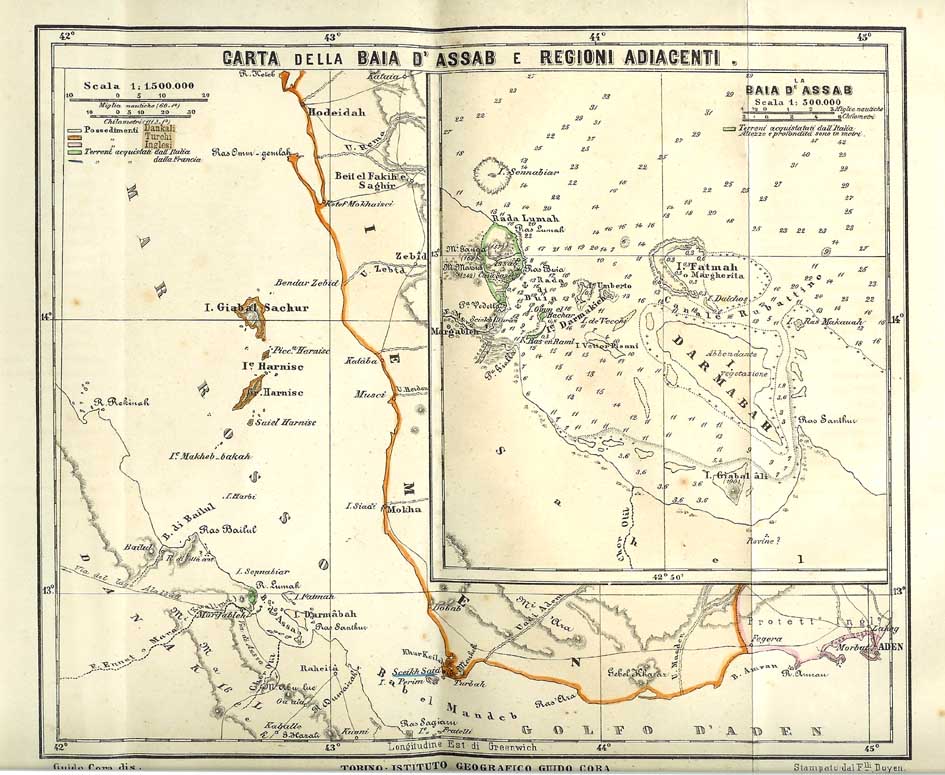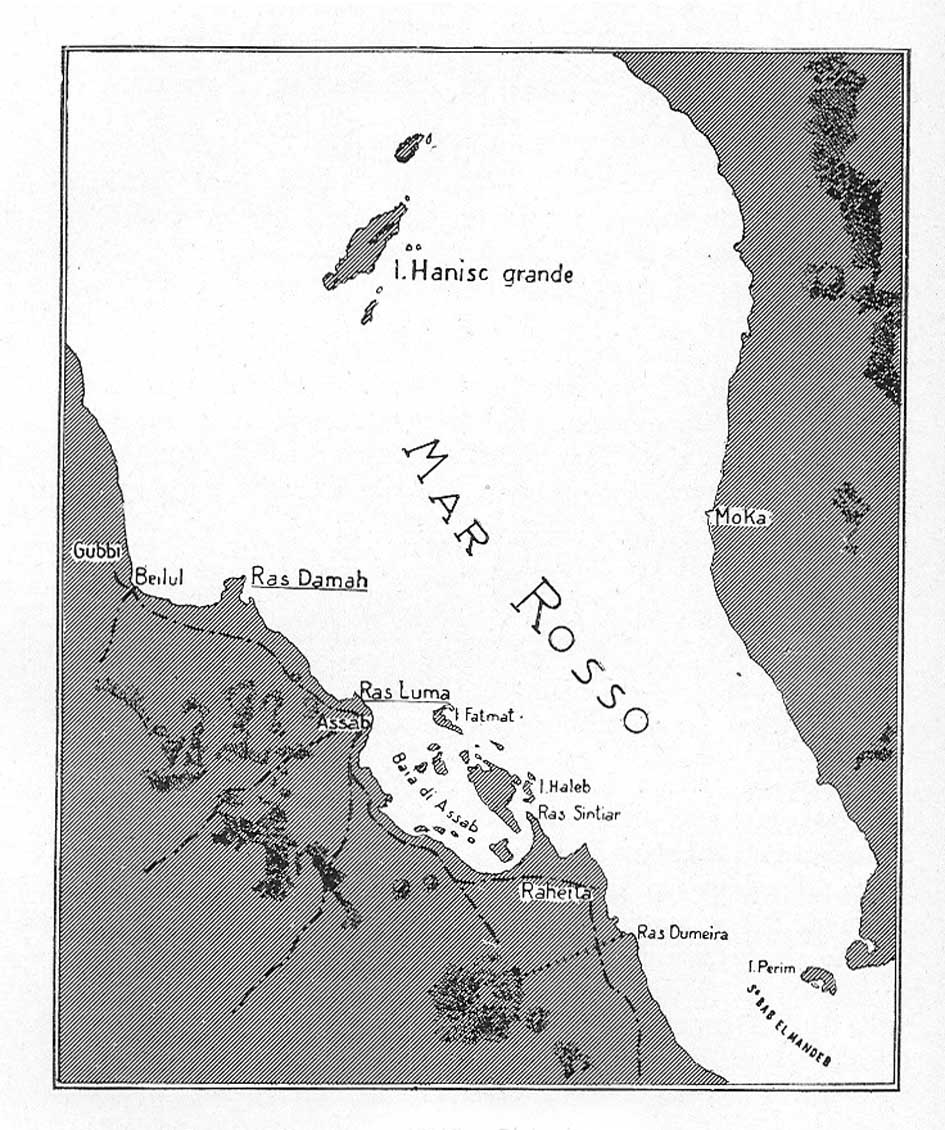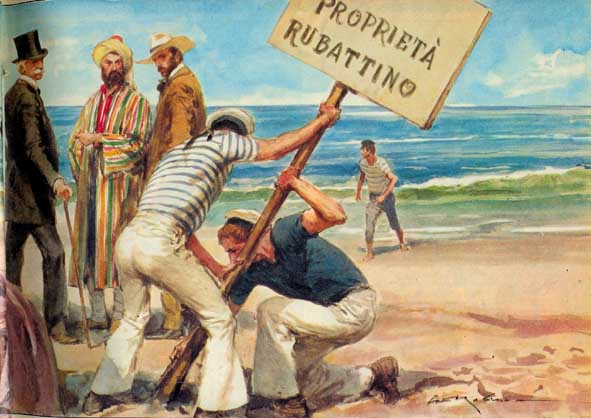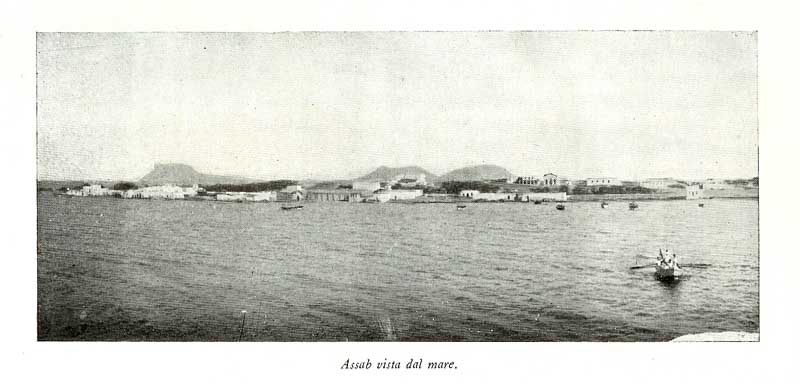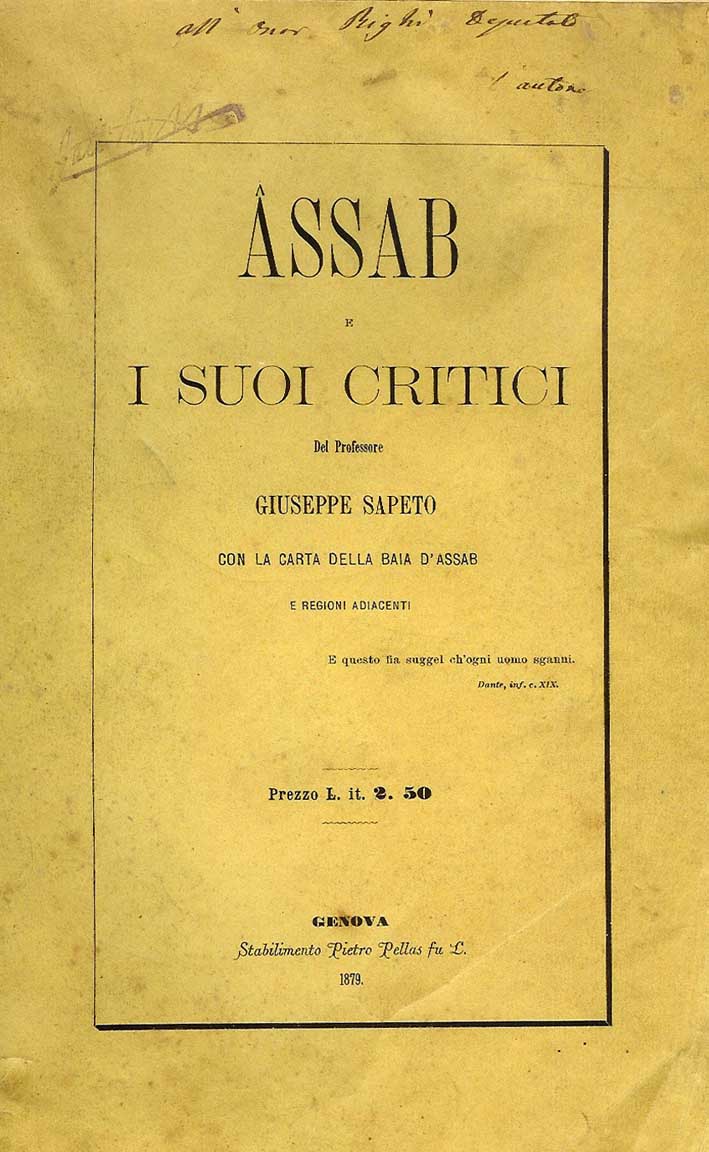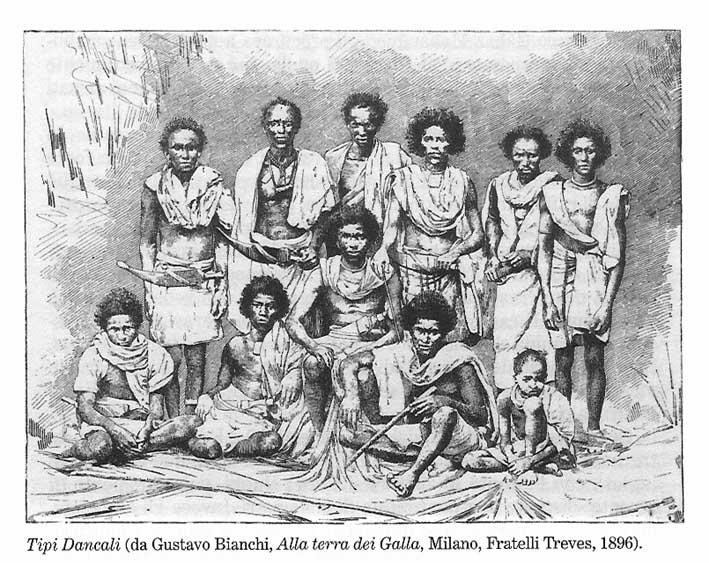|
Nel dibattito che, nella seconda
metà dell'800, divise l'Italia tra sostenitori di colonie o
penitenziarie o libere o politiche, fu la costa africana del Mar
Rosso ad essere prescelta come
base di un primo insediamento italiano. Di qui prese l'avvio quella
che, dal 1° gennaio 1890, fu detta
la Colonia Eritrea,
il primo territorio
coloniale in assoluto di tutta la storia italiana.
Nel 1857 Leone Carpi aveva
chiesto al governo piemontese di occupare una
parte delle coste sud-occidentali
del Mar Rosso1 e
Giuseppe Sapeto, nel 1863,
aveva scritto a Michele Amari,
ministro dell'Istruzione, per consigliargli a sua
volta l'occupazione di uno scalo nello stesso mare2.
Del resto, era il tempo in cui
l'apertura del Canale di Suez si approssimava
sempre più e, a detta di molti,
anche l'Italia avrebbe avuto da guadagnare dalla nuova via marittima3.
Perché non ricordare allora Nino Bixio che, nel 1861, aveva
sostenuto la necessità di stabilirsi in un porto del Mar Rosso, e
sempre in vista dell'apertura
del Canale di Suez? Bixio aveva parlato proprio di Assab, la
località tutt'altro che
paradisiaca che poi fu, nel bene e nel male, il primo insediamento
italiano in Africa4.
C'erano state anche alcune
missioni in Mar Rosso, tra cui quella del 1867 affidata
dal Menabrea, presidente del Consiglio, alla r. n. Ettore
Fieramosca, comandata
dal capitano di fregata Bertelli, ma
l'iniziativa non aveva avuto
nessun seguito, anche perché il Bertelli si era detto contrario
all'occupazione di qualsiasi punto del litorale africano a
sud di Suez, giudicato arido ed inutile5.
L'idea di occupare una località
del Mar Rosso era comunque destinata a divenire
realtà di lì a due anni e per merito di Giuseppe Sapeto un ex
missionario lazzarista che aveva raggiunto l'Etiopia, ovvero l'Abissinia, nel 1838,
fondandovi le missioni
cattoliche e alternando agli incarichi religiosi anche qualche
mandato politico a favore
della Francia (che all'epoca era la vera protettrice delle missioni
in Africa). Propaganda Fide, nel 1861, non gli aveva
rinnovato l'incarico per
varie ragioni e Sapeto aveva deposto l'abito talare. Era poi tornato nel
Mar Rosso per incarico del
Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio ed era
stato ricompensato dall'Amari con la creazione di un'apposita cattedra
di “civiltà e lingua
araba” all'Istituto tecnico di Genova6.
Sapeto non aveva cessato di
tentare la realizzazione dei
suoi progetti nel Mar Rosso.
Nel 1864, inaugurando a Genova il
suo corso di lingua araba, aveva
tenuto un discorso altisonante
in cui è possibile cogliere alcuni passaggi interessanti:
“Noi abbiamo assistito al Risorgimento d'Italia dal suo
sepolcro millenario in mezzo d'immensa necropoli seminata di teschi
di martiri. Ma ciò non basta. L'Italia sente tuttavia l'inerzia del
diuturno suo sonno: il cuore le batte, ma lo spirito suo è
tuttavia infiacchito da regolare torpore, la sua persona rifinita
con le cicatrici, a malapena rimarginate... Ha di mestieri pertanto
che il moto la vivifichi e raffermi in prosperosa esitanza, aitante
col motto taumaturgico surge et ambula, sorgi, cammina e va'
a lavorare nella mia vigna...; attendi al lavoro che ingagliardisce il corpo, che è
l'alito puro delle virtù, la fonte della tua ricchezza e l'ancora di
speranza di tua grandezza e
potenza futura: surge
adunque, et ambula, lavora, lavora, studia e sempre lavora”.
7
Questo era un invito ad agire
al più presto, tanto più che -
osserva Angelo Del Boca - "nel 1869, primo ministro il generale
Luigi Federico Menabrea, conservatore e uomo di fiducia del re, i
tempi sembrano ormai
maturare per dar corso, seppure con grande prudenza, alla prima fase
dell'espansionismo italiano"8.
Il merito di iniziativa di
Sapeto è innegabile e - avverte sempre Del Boca -
anche gli ambienti politici
italiani sono "ben disposti all'avventura coloniale",
compresi la monarchia sabauda,
il governo della Destra allora al potere e parte della
borghesia mercantile.
Nel maggio (o nel giugno) del
1869 Sapeto inoltrò al nuovo ministro
dell'Agricoltura Minghetti9
un Memoriale in cui proponeva l'invio nel Mar Rosso
di un console italiano e l'acquisto di una stazione mercantile e
militare, con lo scopo di
proteggere il commercio italiano. Sapeto sollecitava un pronto
intervento, possibilmente prima dell'imminente apertura del
Canale di Suez che avrebbe
scatenato (come poi fu) nuovi appetiti franco-britannici sulle coste
africane. Proponeva le località di Khur Amera sulla costa
araba del mar Rosso o Dumeira sulla costa africana10.
Sapeto, che "non si da pace se
non trascina anche l'Italia sulle coste
del Mar Rosso"11
ed ha ottenuto "benevole assicurazioni"12
da Minghetti, torna alla
carica nel settembre del 1869, quando è imminente l'apertura del
Canale. Porta, questa
volta al Menabrea, un Promemoria che dovrebbe superare le
lungaggini burocratiche
dei Ministeri degli Esteri e dell'Agricoltura, ma avendo visto
che le cose vanno sempre per le lunghe, si rivolge direttamente al
re Vittorio Emanuele II
tramite il ministro della Real Casa, Gualtiero. Il re prese a cuore
il progetto ed appoggiò Sapeto presso Menabrea che lo ricevette
personalmente13.
A seguito di questo importante
colloquio, il 6 settembre Menabrea scrisse a
Riboty, ministro della Marina,
per sostenere la proposta di Sapeto e chiedere la
nomina di un ufficiale da
affiancare al viaggiatore. Sette giorni dopo, il Ministro,
d'accordo per la ricerca di "una possessione ove si fosse un porto
di scalo che potesse
sorgere a vedetta ed a difesa del nostro commercio" e per l'occupazione
di "una stazione marittima", assicurava l'invio dell'ufficiale
richiesto per la
missione14.
È facile immaginare l'entusiasmo
di Sapeto che rischiava di essere vanificato
dalla "scappatoia dell'audiemus te de hoc iterum", come egli
stesso ebbe a temere15.
Sapeto pensava probabilmente ad
una località della costa asiatica del Mar Rosso, come è cenno
tanto nel Promemoria a Menabrea quanto nella comunicazione
riservatissima di questi a Riboty, del 6 settembre. Egli
parlava di Amera o Omera,
non lontano da Aden, col cui Sultano Ahmed ibn Taleb affermava di
aver stipulato già un
contratto di vendita16.
Il designato della Marina
quale compagno di Sapeto era il contrammiraglio
Guglielmo Acton17,
a cui sarebbero spettati il compito e la responsabilità di
"scegliere il luogo più
conveniente, sotto l'aspetto militare e commerciale, a stabilimento
di colonia".
Il 2 ottobre seguente Sapeto,
presenti due funzionari del Ministero della
Marina, firmò la convenzione
segreta con la quale si impegnava concretamente col governo:
"Dichiaro primieramente che dal R. Governo italiano ebbi incarico di comperare sulle coste dell'Asia o dell'Africa quei terreni,
spiaggie, rade, porti o seni di mare che mi sembrino adatti
allo scopo indicatomi". Per le spese
indispensabili "mi vennero dal
Governo medesimo somministrati i fondi necessari... essendomi stato
aperto per tali compere un credito di lire ottantamila sovra
una casa bancaria di Alessandria d'Egitto. Conseguentemente mi
obbligo di fare le dette compere
a conto e per mandato del Governo italiano... dichiarando...
che ogni terreno, spiaggia, eccetera che io acquisterò, devo cedere
in proprietà del medesimo,
obbligandomi ad immetterlo nel possesso di ogni
cosa da me comprata e a
rinunziare, come con la presente rinunzio, ad ogni diritto
di cui venissi rivestito per effetto dei contratti di acquisto i
quali, sebbene firmati da me, si intendono stipulati per
incarico e conto del Governo medesimo,
non essendo io in ciò che un semplice mandatario"18.
Come si vede e a scanso di ogni
equivoco, Sapeto agiva per conto e per mandato del
Governo italiano; solo in un secondo momento e con sorpresa di
Sapeto spunterà il nome
dell'armatore Rubattino, che si apprestava ad aprire proprio
allora le vie di navigazione da
Genova all'India attraverso il Canale di Suez.
Quindi, l'esame dei documenti
dimostra la "chiara volontà del governo di
effettuare in nome proprio gli
eventuali acquisti"19;
chiarisce anche che Sapeto,
il quale credeva dì essere il
solo protagonista dell'impresa almeno per certi
aspetti, si sarebbe presto
trasformato, suo malgrado e per un processo occulto
(sono parole del viaggiatore), in "agente del signor Rabattino"20.
Sapeto e Acton (questi in
incognito) partirono da Brindisi il 12 ottobre
1869 e raggiunsero il Cairo dove non trovarono l'apertura di credito
pattuita, ma ripresero
ugualmente il mare attraverso i festeggiamenti per l'inaugurazione
del Canale e toccarono Aden il 6 novembre. Qui appresero che Amerà
sulla costa araba era stata già
accaparrata dagli Inglesi (ma la notizia non era vera) e scartarono
l'ipotesi di una occupazione di Sceck Said, non lontano da Aden, di
cui si era impossessata
una compagnia francese. A questo punto, Sapeto e Acton si diressero
a bordo di una saiah araba (un'imbarcazione a un solo albero
con vela latina) verso la costa africana del Mar Rosso. Scartarono
Dumeira per i fondali troppo bassi e scelsero Assab con piena approvazione dell'Acton,
supervisore del lato
tecnico in tutta la faccenda21.
Varie le motivazioni addotte
da Sapeto per giustificare la scelta di Assab22
e che si possono riassumere con le sue stesse parole:
"1. La sua vicinanza allo
stretto di Bab el-Mandeb e il suo facile approdo indicato
dall'isola elevata di Sennabiar e dai monti tagliati a sella, che
additano da lontano il
capo Lumah.
2. La sua posizione rispetto a
Mokha e Hodeida, empori dello Jemen, con i
quali può comunicare con tutti e
due i monsoni.
3. L'attitudine sua a
diventare, come già fu nell'alta antichità, l'emporio
dell'Arabia e dell'Abissinia,
potendovi far capo le carovane che ora vengono a
Massaua, Ras Bailul, Raheita,
Tagerrah e a Zeila" 23.
Giova ricordare che - sottolinea
il Battaglia - nessuna potenza europea ha messo ancora piede su quel
litorale e che almeno al momento non si prospettano incresciose
controversie internazionali. Il luogo è nelle mani di sultanelli
locali, che dipendono solo formalmente dal Sultano Anfari
dell'Aussa (regione ad alcune giornate di marcia da Assab), che è
ritenuto il capo nominale di
tutte le tribù Danakil della costa eritrea, geograficamente
appartenente
all'Abissinia. Ma non è fuori luogo ricordare che l'Egitto avanza
pretese su tutto il
litorale eritreo fino al Capo Guardafuii in Somalia.
Il 15 novembre 1869, a bordo
del Nasser Megid, Sapeto stipula con i fratelli
Hassan e Ibrahim ben Ahmad un
compromesso-contratto24
col quale i due arabi dichiarano (art. 1) che "hanno
venduto e vendono al signor Giuseppe Sapeto il territorio compreso
tra il monte Ganga, il capo Lumah e i due suoi lati". Costo
dell'operazione, la prima della storia coloniale italiana, "seimila
talleri, lasciando... duecentocinquanta talleri di caparra ai
venditori, obbligandosi (Sapeto)
a pagare i rimanenti cinquemila settecento cinquanta talleri fra
cento giorni" (a
decorrere dal 9 dicembre, primo giorno della festa musulmana del
Ramadàn).
La caparra sarebbe stata
considerata perduta, se Sapeto non avesse rispettato i patti e
intanto i fratelli Hassan e Ibrahim "non potranno vendere ad
altri il detto luogo, avendolo già venduto al signor Giuseppe
Sapeto, ed accordatogli cento
giorni al pagamento del prezzo suo"25.
Il territorio acquistato
misurava sei chilometri di base e sei d'altezza.
La relazione sulle operazioni
di acquisto fu stesa da Sapeto e Acton durante la sosta forzata ad
Hodeida nello Yemen e presentata in Italia al nuovo governo
presieduto da Lanza, durato poi in carica fino al 10 luglio 1873. Lo
stesso Acton era stato
avvertito, durante il viaggio di ritorno, che sarebbe diventato il
nuovo ministro della
Marina.
La ratifica all'operato di Sapeto
fu concessa26, ma
lo stesso Sapeto venne esortato a non compromettere in nessun
modo il governo che "non deve punto
figurare" e intendeva "limitarsi
ad accordare soltanto la dovuta protezione al
commercio e ai sudditi nazionali
che si stabiliranno in quei paraggi27.
La notizia dell'acquisto di Assab
era giunta a Firenze, quando la crisi del ministero
Menabrea era già in atto, ma non era stato ancora costituito il
nuovo gabinetto Lanza.
Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 26 novembre, il
gabinetto dimissionario,
considerando che la somma da Sapeto pattuita per
l'acquisto della località
ammontava a 80 mila lire (in sostanza, quanto gli era
stato concesso in precedenza),
deliberò di prelevare tale somma "da uno dei capitoli del Bilancio ordinario della Marina, ove potranno esservi delle
economie", salvo a
chiedere dopo l'autorizzazione parlamentare con un progetto di
legge, una volta proceduto al definitivo acquisto di Assab. Osserva
a ragione De Leone che
tale "tempestiva deliberazione" fu quella che consenti la conservazione
di Assab che altrimenti il gabinetto Lanza, col Visconti Venosta
agli Esteri, avrebbe lasciato cadere nel nulla28.
In realtà, Lanza era
nettamente contrario ad avventure colonialistiche e temeva
di compromettersi con i gabinetti di Londra e Parigi. Forse già
Menabrea aveva avuto dei contatti con Rubattino29
perché si assumesse l'onere del perfezionamento
dell'acquisto di Assab, seppure sotto la tutela del governo; certo è
che Lanza avviò e completò i contatti coll'armatore, lo stesso che
aveva fornito le navi a Pisacane e a Garibaldi, "l'uomo forse più
audace - dice Battaglia -
della nostra borghesia risorgimentale"30;
colui che era riuscito a farsi
approvare dal Parlamento la convenzione per l'istituzione di una
linea di navigazione Genova-Alessandria d'Egitto e stava per
inaugurare l'altra da Genova all'India.
Fu a questo punto che Sapeto
si trovò, come già sottolineato, a dover
operare con Rubattino. Il
2 febbraio 1870, a Firenze ancora per poco capitale del Regno, fu
sottoscritta una scrittura privata fra Agostino Torsello,
procuratore di Rubattino e i ministri della Marina, Acton,
dell'Agricoltura Industria e Commercio, Castagnola, degli Esteri,
Visconti Venosta, e dei Lavori Pubblici, Gadda. Con essa l'armatore
Rubattino s'impegnava a far partire entro il 12 dello stesso mese un
suo vapore con 200
tonnellate di carbone a bordo per la R. Marina, per sbarcarle
ad Assab, e ad "acquistare apparentemente a suo nome, ma realmente
nell'interesse e nel conto
del Governo quei tratti di terreno situati nella baia di
Assab che gli verranno indicati dal prof. Giuseppe Sapeto, il quale
a questo effetto verrà
imbarcato e mantenuto sul battello a vapore che sarà spedito dal signor
Rubattino".
Il governo italiano avrebbe
fornito il denaro per l'acquisto dei terreni e pagato il
consumo di carbone e le spese di passaggio per Suez. A Rubattino
sarebbe toccata una porzione di
terreno "per una stazione ad uso della sua compagnia di
navigazione". La Convenzione sarebbe rimasta "segreta" finché
il governo non avesse ritenuto conveniente fare della pubblicità31.
Nonostante questo documento
scritto, Sapeto ebbe varie difficoltà da affrontare
prima di salire su un'altra nave diretta in Mar Rosso; anche
Acton rischiava di essere
coinvolto nei timori del gabinetto Lanza, per quanto
fosse certamente più schierato
per Sapeto.
Finalmente, l'8 febbraio Sapeto
riceveva da Acton
istruzioni riservatissime32
- la nave della Marina sarebbe stata l'avviso Vedetta
col comandante Ruggiero - e
aveva la certezza di dover agire "in nome del signor Rubattino"; lui
stesso prendeva imbarco sull'Africa della Rubattino, che
inaugurava la linea per Bombay, il giorno dopo la partenza della
nave, pertanto da Livorno e non da Genova. Era il 14 febbraio. A
bordo si trovavano anche Arturo Issel e
Odoardo Beccari, due noti
viaggiatori che lo avrebbero accompagnato fino ad Assab per poi
proseguire per Massaua e Cheren allo scopo di visitare la colonia
agricola
fondata dal padre Stella33;
e un uomo di fiducia di Rubattino, il cav.
Grandoni34.
L'8 marzo, o forse il 9, la nave
raggiunse Assab: mancava pochissimo alla
scadenza dei famosi "cento giorni", Sapeto e gli altri discesero dall'Africa
il giorno seguente,
mandarono a chiamare i due sultani del primo compromesso
ed appresero che, nelle settimane
precedenti, varie minacce erano state loro rivolte per aver venduto
all'Italia una parte della baia di Assab. C'era da vedere in
tutto questo le mene sia di funzionari egiziani sia di agenti
inglesi dell'opposta sponda del Mar Rosso.
A questo punto Sapeto dovette
impegnarsi a fondo per tranquillizzare i due Sultani che, d'altra
parte, giocavano al rialzo per ottenere più denaro e, avendo
Ibrahim e Hassab ben Ahmad
affermato che nel contratto del 15 novembre
1869 non si era parlato della
baia di Buia appartenente ad un altro capo indigeno, ovvero il
Sultano Abdalla Sciahim, Sapeto giunse alla conclusione che
fosse meglio redigere un nuovo
contratto con ampliamento del territorio acquistato
in novembre e relativo aumento del corrispettivo in denaro35.
L' 11 marzo 1870, Hassan e
Ibrahim ben Ahmad e Abdalla Sciahim stipularono a bordo dell'Africa il nuovo contratto36,
sottoscritto da Sapeto e dal Buzzolino,
comandante della nave: questi ultimi erano indicati come
rappresentanti di Rubattino. Vi si poteva leggere che "i
suddetti Sultani vendono, come hanno
venduto, ai signori Giuseppe Sapeto e Andrea Buzzolino il tratto di paese
e di mare racchiuso tra
Ras Lumah e la gola di mare chiamata Alala e il monte
Ganga, senza nessun onere né
dipendenza da parte dei compratori, i quali
sborsano ai medesimi venditori
sopra nominati il prezzo convenuto, consistente in scudi o
talleri di Maria Teresa, ottomila e cento". Il contratto affermava
inoltre che i Sultani avrebbero aspettato "il pagamento totale del
nuovo territorio... e ciò pel tempo che tornerà il vapore che sarà mandato in Aden per ivi
cambiare le lire
sterline" (intanto, avevano intascato l’acconto... in talleri di
Maria Teresa seicento e rupie trecento ottantotto"). Ai nuovi
possessori sarebbe stata lasciata
"ampia e intera facoltà di ivi stabilirsi come credono meglio e di
inalberarvi la loro bandiera nazionale in segno della sovranità assoluta sul
luogo".
Il problema della moneta in cui
effettuare il pagamento era sorto per non
aver voluto i Sultani accettare le lire sterline, ma solo "talleri
effettivi di Maria
Teresa", la moneta dominante nel Mar Rosso.
Il 13 marzo 1870, la bandiera
italiana saliva sul promontorio della baia di Assab tra le salve di
cannone dell'Africa. Il giorno 14 alcunii pali in legno
all'estremità nord e sud
del possedimento fissavano l'indicazione "Proprietà
Rubattino comprata agli 11 marzo 1870".
Ecco cosa poi scrisse Sapeto in
“Assab e i suoi critici”: "Tornati a bordo in sul meriggio,
salutammo il nostro vessillo tricolore
con ventun colpi di cannone, seguitati da generale evviva
all'Italia, al re, al
Rubattino, ecc. ecc. Io feci distribuire una rupia a ciascuno dei
marinai, e dare loro una
cassa di vino d'Asti per fare un po' di baldoria. Ai 14 si ritornò
sul continente e
s'inchiodarono sopra pali, solidamente conficcati in terra, ai capi
nord e sud del nostro
territorio, due tasselli con l'epigrafe: Proprietà Rubattino
comprata agli 11 marzo 1870"38.
L'acquisto precedente era stato
dunque perfezionato ed accresciuto per merito di Sapeto. Il governo
italiano non figurava ufficialmente, come già stabilito.
Tutto era stato effettuato secondo la volontà di Lanza e Visconti
Venosta.
Il 15 marzo Sapeto si recò
presso il Sultano di Raheita, Berehan Dini, per concordare anche
l'acquisto dell'isola di Omm el-Bahar, di fronte alla baia di Assab.
Questa operazione gli costò non poche insistenze, Finalmente Berehan
si convinse a cedere in
affitto a Sapeto quella ed altre isole per un periodo di dieci anni
con versamento annuale
anticipato di un canone di cento talleri (1000 in tutto,
dunque), con possibilità
di acquistarle definitivamente, alla scadenza dei dieci anni, per un
totale di 2000 rupie (ovvero circa 1000 talleri). Il contratto fu
firmato l'indomani, 16 marzo39.
Dopo la firma e il versamento
della prima rata, Sapeto e i compagni raggiunsero
l'isola di Omm el-Bahar per scaricare il carbone per l'avviso
Vedetta, di cui si attendeva ancora l'arrivo. Poi Sapeto
si diresse ad Assab e quindi ad Aden, territorio britannico, per
procedere al cambio del denaro in talleri di Maria
Teresa40.
Da Aden l'Africa proseguì per Bombay e Sapeto, Issel,
Beccari e Antinori, non
vedendo giungere la Vedetta, si servirono di un sambuco
per rientrare ad Assab. Era il 31 marzo e ai tre Sultani
firmatari della Convenzione dell'11 marzo fu versata la somma
prestabilita.
Nei giorni seguenti non si
verificarono fatti particolari. I tre scienziati partirono
per la loro destinazione e Sapeto, rimasto solo, ebbe una serie di
contatti con le popolazioni locali, mentre la Vedetta,
che aveva tardato l'arrivo per un
brutto incidente a Suez, compì
alcuni lavori idrografici. Quando poi il 22 aprile
il vapore Affrica fece
ritorno da Bombay, Sapeto preferì restare ancora qualche
giorno e imbarcarsi quindi sulla
Vedetta il 25 aprile. La casetta, costruita appositamente
nella rada di Buia, fu chiusa e affidata in consegna a due indigeni41.
L'acquisto di Assab era costato
al governo 104.100 lire di cui 55.000 a carico del bilancio
dell'Interno e le rimanenti a carico dei Ministeri della Marina,
Agricoltura, Lavori Pubblici ed Esteri. Più esattamente, delle
104.100 lire, 51.100 erano per
il rimborso a Rubattino dei viaggi, 41.200 per i pagamenti ai
Sultani, 12.000 per le competenze spettanti a Sapeto42.
Al rientro in Italia Sapeto fu
accolto da trionfatore dalla Camera di Commercio dì Messina:
"Mercé vostra quest'Italia, che diede all'Europa un nuovo mondo,
possiede anch'essa, al di là de' mari che la bagnano, un angolo
su cui inalberò il tricolore; da
cui propagherà i suoi commerci e la sua civiltà”43.
Però, ebbe presto inizio il decennio dei dubbi e delle critiche.
Sapeto da un lato cercò di dare un seguito alle sue iniziative, il governo italiano dall'altro
temeva il già fatto e forse, potendo, sarebbe tornato
indietro. Per molto tempo Assab cadde
nell'oblìo44.
Per di più, l'Egitto sollevò ampie riserve sul diritto dell'Italia
ad occupare tenitori che il Khedivé egiziano e la Sublime
Porta ritenevano intoccabili
da altri45.
Non a caso quattro giorni dopo
la partenza di Sapeto da Assab, cioè il 29
aprile, la corvetta egiziana Khartoum effettuò un sopralluogo
nella baia: i suoi marinai sfasciarono la casetta di Sapeto,
minacciarono duramente i Sultani che avevano ceduto parte del
litorale all'Italia, lasciarono a terra un distaccamento militare
poi richiamato46.
Inizio più incerto non si
sarebbe potuto avere, ma l’Italia aveva messo piede in Africa
Orientale, nel bene e nel male47.
APPENDICE DOCUMENTARIA
CONVENZIONE
FIRMATA DA HASSAN BEN AHMAD E
IBRAHIM BEN AHMAD, SULTANI DI ASSAB E DAL PROFESSORE GIUSEPPE SAPETO,
PER LA VENDITA DEL TERRITORIO COMPRESO FRA IL MONTE GANGA, IL CAPO
LUMAH ED I DUE SUOI LATI.
Assab,
15 novembre 1869
Gloria a Dio.
Essendo il giorno di lunedì
undecimo del mese di sciaban dell'anno 1286 secondo il
computo degli islamiti, e il
giorno 15 del mese di novembre dell'anno 1869 secondo
l'èra degli europei, Hassan ben
Ahmad, Ibrahim ben Ahmad, fratelli, e il signor Giuseppe
Sapeto, resisi a bordo del Nasser-Megid, barca di Said-Auadh, e
fatto atto di presenza,
stipularono quanto segue al cospetto dei testimoni:
1° I fratelli sopraddetti Hassan
ben Ahmad ed Ibrahim ben Ahmad, Sultani di Assab,
hanno venduto e vendono al signor Giuseppe Sapeto anzidetto il
territorio compreso tra
il monte Ganga, il capo Lumah e i due suoi lati; perlochè il dominio
del detto territorio
apparterrà al signor Giuseppe Sapete, tostoché questi ne avrà
sborsato il prezzo
avendoglielo essi spontaneamente venduto, volontariamente e con
retta intenzione.
2° I fratelli suddetti
giurano, sul Corano della Distinzione, che né essi né la
gente loro faranno perfidie
agli Europei che verranno ad abitare il paese proprietà del signor
Sapeto.
3° II signor Giuseppe Sapeto
compra il detto luogo per seimila talleri, lasciando
perciò duecentocinquanta talleri
di caparra ai venditori, obbligandosi a pagare i rimanenti cinquemila settecento cinquanta talleri fra cento giorni
decorrenti dal primo di
ramadan fino ai dieci del mese di heggiah. Ché se il signor Giuseppe
non tornasse più, né altri venisse in sua vece nel tempo fissato, la
caparra andrebbe perduta. I fratelli poi
soprannominati non potranno
vendere ad altri il detto luogo, avendolo già venduto al
signor Giuseppe Sapeto, ed
accordatogli cento giorni al pagamento del prezzo suo.
Questo è in contratto passato tra
il signor Giuseppe Sapeto, e i fratelli Hassan ben Ahmad ed Ibrahim
ben Ahmad, alla presenza dei testimoni Mahamad Abdi, Ahmad
Ali, Said Auadh, scrivano, Abd
Allah ben Duran.
Accettato e sottoscritto dai
contraenti:
hassan
ben ahmad -
ibrahim ben ahmad
giuseppe
sapeto
CONVENZIONE
firmata
dai sultani abdallah sciahim, hassan ben ahmad e ibrahim
ben
ahmad, e dai signori giuseppe sapeto e capitano andrea buzzolino,
per la vendita del tratto di paese e di mare racchiuso fra ras lumah
e la gola di mare alala e il monte ganga.
Assab,
11 marzo 1870
Gloria a Dio.
Nel giorno nove del mese dell'heggi
dell'anno 1286 secondo l'èra musulmana, agli undici del mese di
marzo 1870 secondo l’èra volgare, il Sultano Abdallah Sciahim e i
Sultani Hassan ben Ahmad ed Ibrahin ben Ahmad
da una parte, e i signori
Giuseppe Sapeto ed Andrea
Buzzolino, capitano del vapore l'Affrica dall'altra,
radunatisi a bordo
del vapore medesimo, vennero alla stipulazione del seguente
contratto.
I suddetti Sultani vendono, come
hanno venduto, ai signori Giuseppe Sapeto ed
Andrea Buzzolino il tratto di
paese e di mare racchiuso tra Ras Lumah e la gola di mare
chiamata Alala e il monte Ganga, senza nessun onere né dipendenza da
parte dei compratori, i
quali sborsano ai medesimi venditori, sopra nominati, il prezzo
convenuto, consistente in scudi o talleri di Maria Teresa
ottomila e cento.
Ma siccome i Sultani Sciahim,
Hassan e Ibrahim suddetti non intendono essere pagati in lire
sterline, ma in talleri effettivi di Maria Teresa, così si
contentano per il
presente di ricevere talleri di Maria Teresa seicento e rupie
trecento ottantotto, dichiarando di aspettare il pagamento totale dei talleri ottomila e cento al
ritorno del vapore da Aden.
Intanto i suddetti Hassan ed
Ibrahim, figliuoli di Ahmad, dichiarano e riconfermano
che il signor Giuseppe Sapeto, secondo il contratto del 15 novembre
1869, venne, nel termine assegnato, allo sborso del prezzo di Lumah
e riconfermano di aspettare il
pagamento totale del nuovo territorio che, unitamente al Sultano
Abdallah Sciahim,
vendono, come hanno venduto, ai signori Giuseppe Sapeto e Andrea
Buzzolino nei limiti
sopradescritti, e ciò pel tempo che tornerà il vapore che sarà
mandato in Aden per ivi
cambiare le lire sterline in talleri di Maria Teresa; e confessano
aver ricevuto l'acconto
sudetto in talleri di Maria Teresa seicento e rupie trecento
ottantotto, lasciando ai nuovi possessori dei paesi comprati
ampia ed intera facoltà di ivi stabilirsi come credono meglio e di
inalberarvi la loro bandiera nazionale in segno della sovranità
assoluta sul luogo.
Tanto fu stipulato dai Sultani
Abdallah Sciahim, Hassan ed Ibrahim, e dai signori
Giuseppe Sapeto ed Andrea
Buzzolino, come rappresentanti dei signori R. Rubattino e
C.
Questo contratto essendo stato
tradotto letteralmente in arabo ai suddetti Sultani,
questi ne hanno approvato il
contenuto e la vendita stipulata, hanno apposto la loro
firma e sigillo, unitamente ai compratori Giuseppe Sapeto e Andrea
Buzzolino, alla presenza
degli infrascritti testimoni dichiarando aver stipulato il presente
contratto in tutta buona
fede, e di dargli perciò tutto il valore legale ancorché non sia
redatto nelle forme usate in atti consimili.
Infine Giuseppe Sapeto e Andrea
Buzzolino, come rappresentanti dei Signori R.
Rubattino e C., dichiarano che
con questo contratto non intendono in nessun modo
infirmare gli accordi che prima
dell'atto presente fossero passati tra il Giuseppe Sapeto
e il signor Raffaele Rubattino ed
altri aventi causa o cointeressati.
In approvazione di quanto
retro sottoscrivono, mancando di sigillo.
|
giuseppe sapeto |
HASSAN BEN AHMAD
|
|
A.
buzzolino |
abdallah sciahim |
|
ibrahim ben ahmad |
|
|
Testimoni: abdallah eben - aali chesi |
|
NOTE
1 L. CARPI, Delle colonie
e dell'emigrazione italiana all'estero, Milano 1874, vol. II, p.
17.
2 MINISTERO AFFARI ESTERI,
L'Italia in Africa, serie storica, vol. 1°, Etiopia-Mar Rosso,
tomo I (1857-1885), a cura di C. GIGLIO, Roma 1958, p. 101.
3 Sulla storia del Canale
di Suez, cfr. MINISTERO AFFARI ESTERI, L'Italia in Africa, serie
storica, voi. IV, Luigi Negrelli e il Canale di Suez, tomi I e
II (1846-1869), a cura di A. Scaglione, Roma 1972.
4 F. BANDINI, Gli italiani
in Africa (Storia delle guerre coloniali,1882-1943), Milano
1980, p. 11.
5 GIGLIO, op. cit., pp.
101-102.
6 Ivi, pp. 102-103. Per più
ampie notizie biografiche su Giuseppe Sapeto, cfr. G. PUGLISI,
Chi è? dell'Eritrea, Asmara 1952, p. 267. Sempre sul Sapeto, cfr.
l’Allegato “Viaggi e viaggiatori” all’indirizzo internet
www.economia.it/Economia+Bologna/paginedafrica.htm
esplicativo della Mostra “Pagine d’Africa” (Il primo
colonialismo italiano nelle biblioteche dell'università da Assab
a Massaua 1869-1885), tenutasi dal 9 al 23 aprile 2005 presso
l’Università di Bologna. Altri allegati che potranno essere
utilmente letti sono “Cronologia”, “Quadro storico” e “Assab”.
7 G. GIACCHERO-G. BISOGNI,
Vita di Giuseppe Sapeto, Firenze 1942, p. 187 (citato in
MINISTERO AFFARI ESTERI, L'Italia in Africa, serie storica, vol.
II, Le prime ricerche di una colonia e la esplorazione
geografica, politica ed economica, a cura di E. DE LEONE, Roma
1955, p. 78).
8 A. DEL BOCA, Gli
Italiani in Africa orientale (Dall'Unità alla marcia su Roma),
Bari 1976, p. 36.
9 Si era nel terzo
Gabinetto Menabrea (13 maggio-14 dicembre 1869).
10 GIGLIO, op. cit., pp.
103-104.
11 R. BATTAGLIA, La prima
guerra d'Africa, Torino 1958, p. 80.
12 GIGLIO, op. cit., p.
104.
13 G. SAPETO, Assab e i
suoi critici, Genova 1879, pp. 15-16.
14 GIGLIO, op. cit., p.
104.
15 BATTAGLIA, op. cit., p.
81.
16 DE LEONE, op. cit., pp.
78-80; ma GIGLIO (op. cit., p. 125, nota 7) nega l'esistenza di
questo contratto per Amera, attribuendolo soltanto alle
“contraddizioni e vanterie infondate non infrequenti nella
condotta e negli scritti del Sapeto”.
17 Guglielmo Acton
proveniva dalla marina napoletana e aveva combattuto a Lissa.
Era un buon conoscitore di arabo.
18 DE LEONE, op. cit., p.
80.
19 Ivi, p. 81.
20 SAPETO, op. cit., p.
16.
21 Su queste vicende,
cfr. DE LEONE, op. cit., p. 81.
22 Nel suo volume Assab e
i suoi crìtici (del 1879) è scritto che Assab è la parte
dell'Abissinia "dove scorre miele e latte" (citato in A. DE
JACO, Di mal d'Africa si muore, Roma 1972, pp. 13-15).
23 GIACCHERO-BSISOGNI,
op. cit., p. 201.
24 Lo si legga
nell'Appendice del presente lavoro, documento n. 1.
25 L'originale di questo
contratto non è stato mai rinvenuto in nessun archivio. Fu,
comunque, stampato in MINISTERO AFFARI ESTERI, Trattati,
convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi
all'Africa, vol. I, Roma 1906, pp. 25-26 (è reperibile in
numerose altre pubblicazioni).
26 GIGLIO, op. cit., p.
106.
27 BATTAGLIA, op. cit, p.
86.
28 DE LEONE, op. cit., p.
82.
29 Così DEL BOCA, op.
cit., p. 38.
30 BATTAGLIA, op. cit., p.
82. Sulla personalità del Rubattino, cfr. le pp. 82-84. Si veda,
inoltre, G. ROCHAT, // colonialismo italiano, Torino 1973, pp.
20-21.
31 DE LEONE, op. cit., pp.
82-83.
32 Sono riprodotte
integralmente in MINISTERO AFFARI ESTERI, L'Italia in Africa,
serie storica, vol. I, Etiopia-Mar Rosso, tomo II, Documenti
(1859-1882), Roma 1959, pp. 7-8.
33 Per le notizie
biografiche su questa interessante figura, cfr. F. SURDICH,
Alcune lettere inedite di padre Stella, in "Atti e Memorie
della Società Savonese di Storia Patria", n.s., XV, (1981), pp.
227-230. Note biografiche su Issel e Beccari, in S. ZAVATTI,
Uomini verso l'ignoto, Ancona 1979, rispettivamente p. 215 e 46.
34 A Suez o ad Alessandria
d'Egitto l'Affrica accolse a bordo un altro personaggio, il
marchese Orazio Antinori, anch'egli noto esploratore, sul quale
cfr. ZAVATTI, op. cit., pp. 28-29.
35 Su queste vicende, cfr.
MINISTERO DELLA GUERRA, Comando del Corpo di Stato Maggiore
(Ufficio Storico), Storia militare della Colonia Eritrea, Roma
1935, vol. I, pp. 24-25.
36 Anche questo mai
rinvenuto negli archivi, come avverte GIGLIO, op. cit., p. 128,
nota 22. Lo si legga nell'Appendice del presente lavoro,
documento n. 2.
37 GIGLIO, op. cit., p.
108.
38 SAPETO, op. cit., p.
32.
39 GIGLIO, op. cit., pp.
108-109. Lo stesso Giglio avverte che questa è l'unica
stipulazione di Sapeto che non è stata mai pubblicata.
40 Ivi, p. 109.
41 Ivi, p. 110.
42 DEL BOCA, op. cit., p.
40, nota 16.
43 Ivi, p. 40.
44 Sulle polemiche e sul
silenzio cfr. GIGLIO, op. cit., pp. 110-114. Si vedano anche R.
RAINERO, L'anticolonialismo italiano di Assab ad Adua, Milano
1971, pp. 21-42 e, in un ambito più ampio, M. ROMANDINI, II
problema coloniale in Italia dopo l'acquisto di Assab, in
"Quaderni di Studi Etiopici" (Asmara), 5,1984, pp. 20-33. Sulla
politica italiana del raccoglimento dopo il 1870, cfr. J.L.
MIÉGE, L'imperialismo coloniale italiano dal 1870 ai nostri
giorni, Milano 1976, pp. 24-27.
45 GIGLIO, op. cit., pp.
115-121.
46 DEL BOCA, op. cit., pp.
43-44.
47
Giuseppe Sapeto ritornò ad Assab il 25 dicembre 1879 per saldare
i canoni di affitto dell'accordo col Sultano Berehan di Raheita
e per firmare altri contratti (cfr. DE LEONE, op. cit., pp.
90-93), ma non si trattò di una missione facile. In Italia
Cairoli era presidente del Consiglio. Il 26 gennaio 1881, fatte
le consegne al R. Commissario Civile Giovanni Branchi, Sapeto
rimpatriò e restò in servizio come professore di arabo fino al
1° ottobre 1891. Morì, praticamente dimenticato, il 25 agosto
1895. La Convenzione 10 marzo 1882, firmata a Roma, determinò
poi la cessione dei territori acquistati in Eritrea dalla Socieà
Rubattino al R. Governo ormai intenzionato ad agire in prima
persona (si veda il documento in MINISTERO AFFARI ESTERI,
L'Italia in Africa, serie storica, La politica coloniale
dell'Italia negli atti, documenti e discussioni parlamentari, a
cura di G. PERTICONE, Roma 1965, pp. 183-185).
|