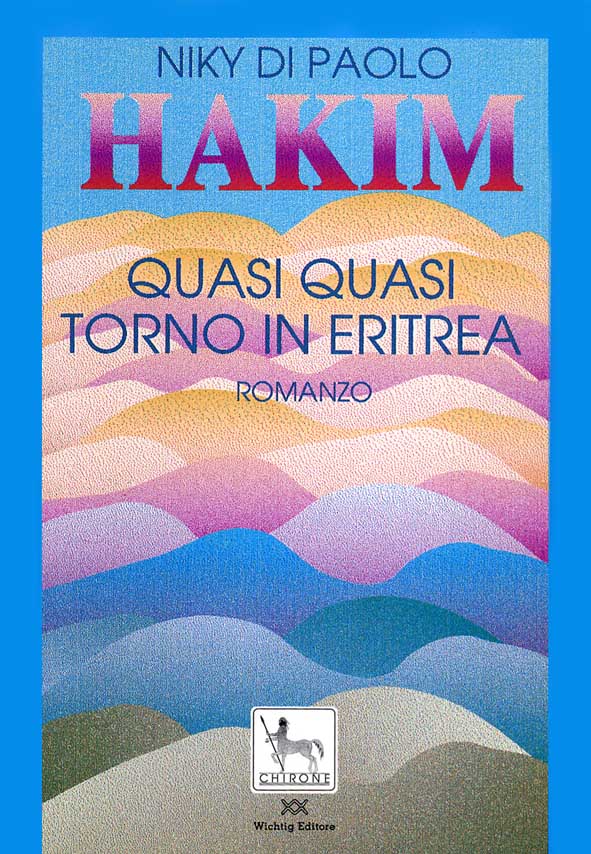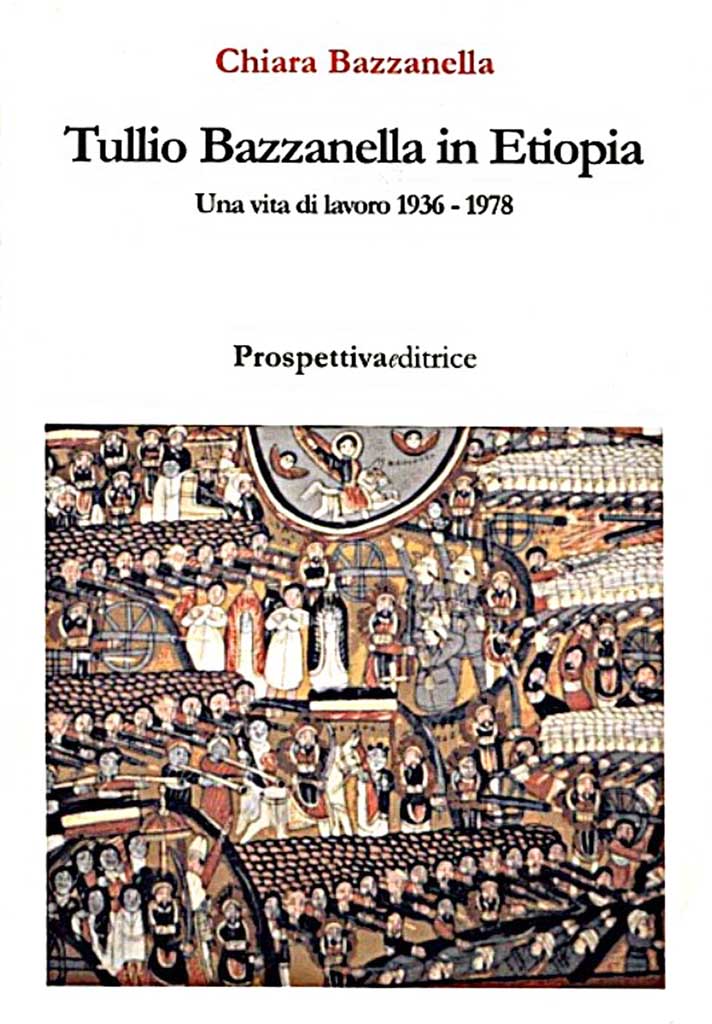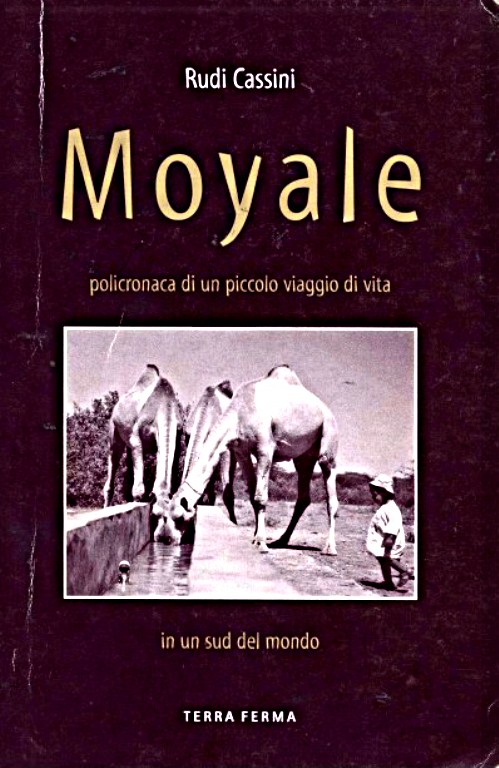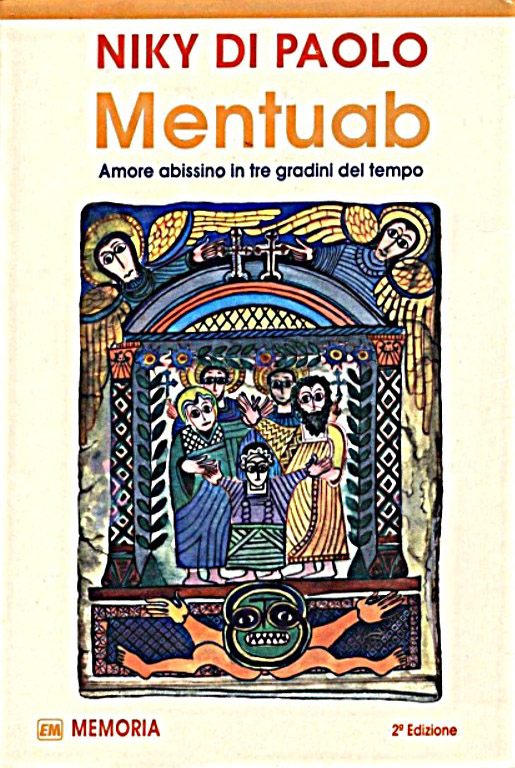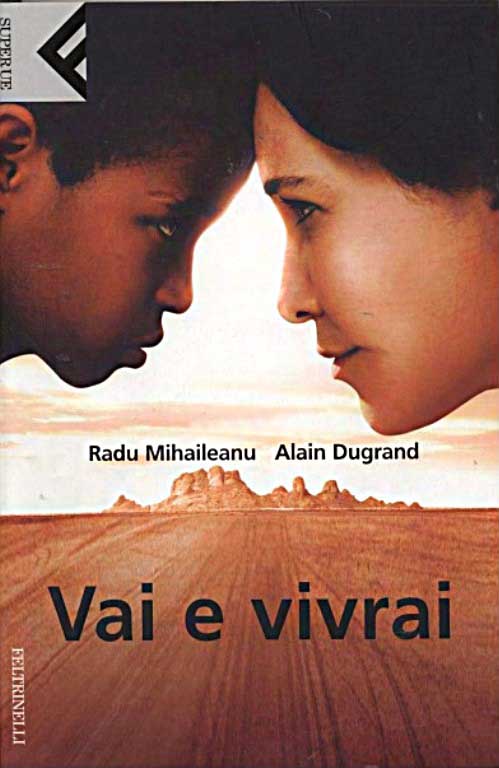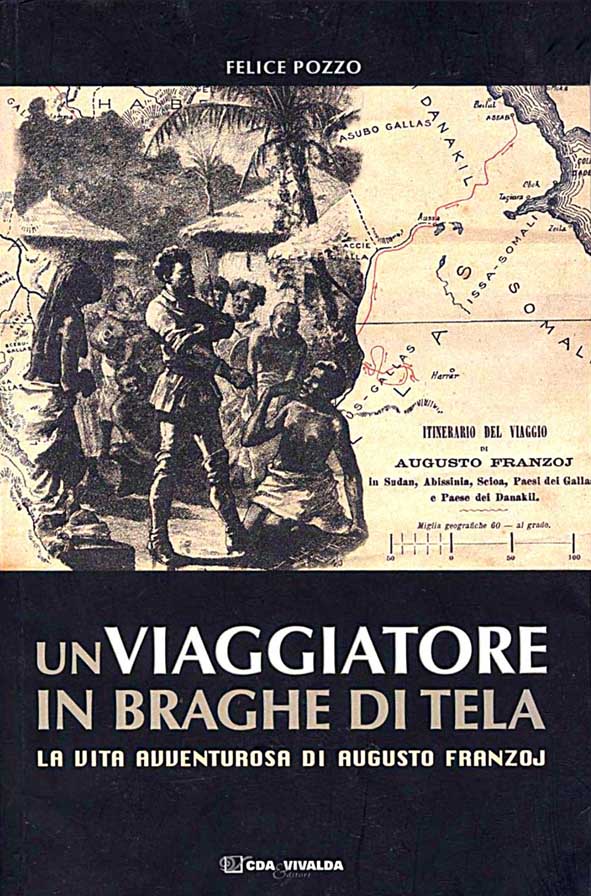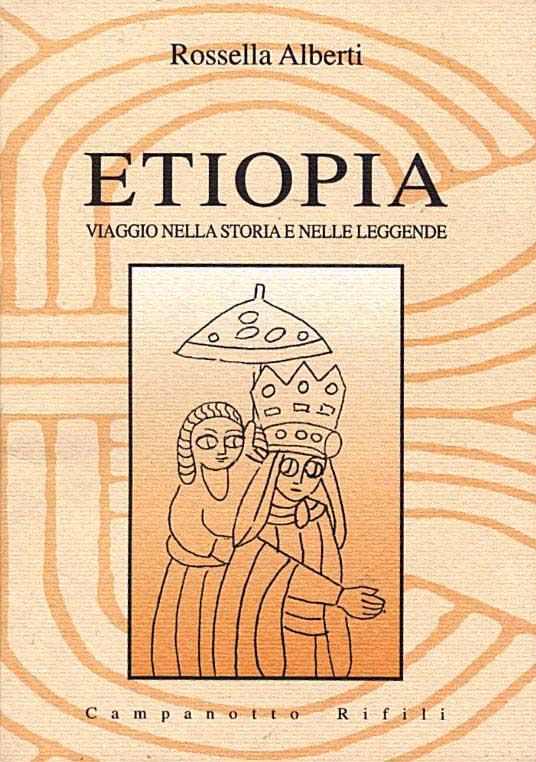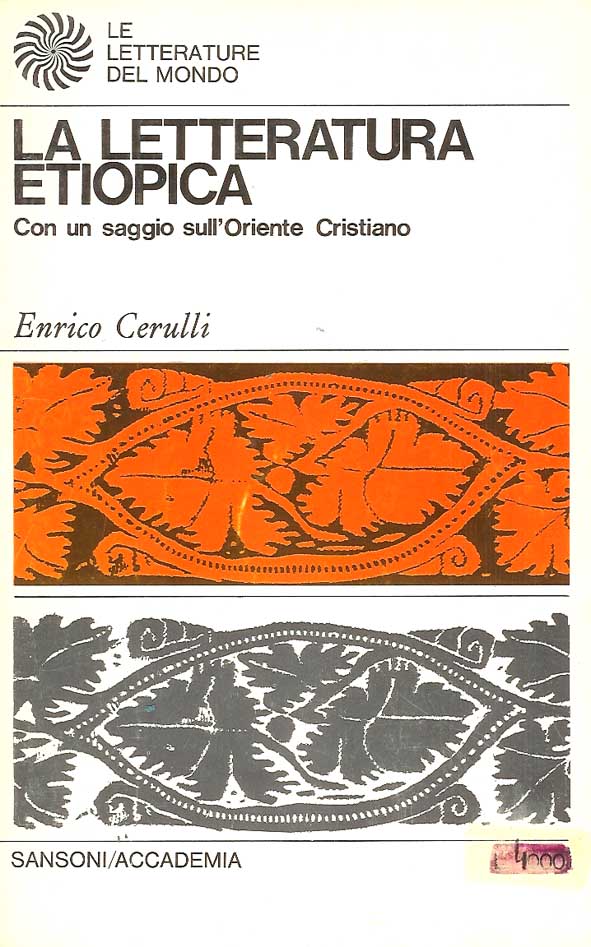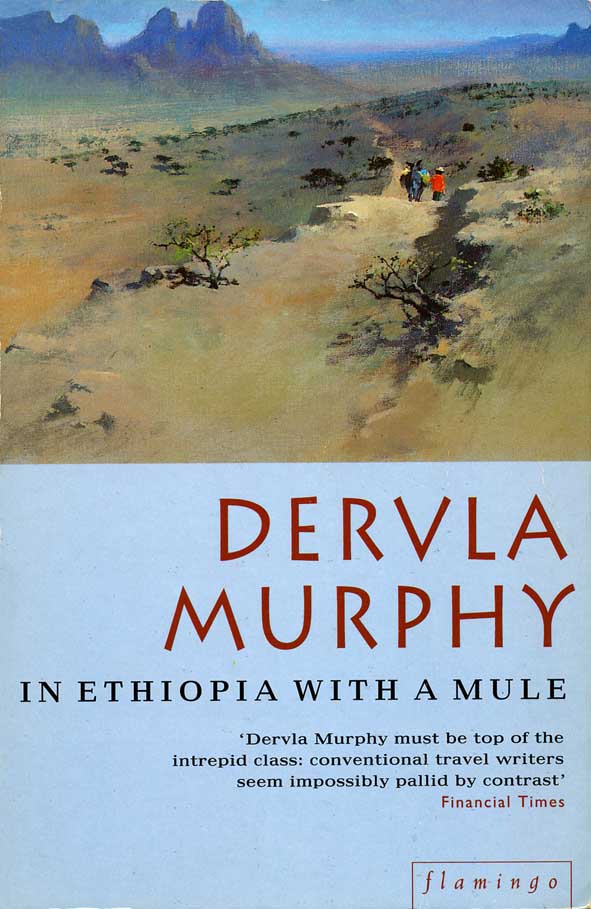|
Le recensioni di Mirella Pron |
|
|
|
HAKIM- quasi quasi torno in Eritrea |
|
Niky Di Paolo, edizioni Wichtig |
|
I protagonisti del romanzo sono ragazzi degli anni sessanta, accomunati dal luogo dove vivono, l’Eritrea, in cui molti di loro sono nati. Alcuni hanno un grande attaccamento per quella terra, pur essendo la loro origine lontana, altri desiderano addirittura donarsi interamente ad essa, altri ancora ne sfruttano solo i lati positivi, aspettando di andarsene. Marco è italiano, nato e cresciuto in Eritrea, Tesfai è eritreo. Dopo il liceo si iscrivono entrambi alla facoltà di medicina ad Asmara che prevede gli ultimi esami e la laurea in Italia. Il libro segue per tutto il suo svolgimento la storia semplice di questi ragazzi, le loro speranze, gli amori corrisposti o impossibili, la vita quotidiana, le conquiste e le difficoltà. Una storia che si intreccia con la Storia ufficiale, con l’annessione dell’Eritrea all’Etiopia e con la nascita del Fronte di Liberazione al quale aderiranno molti giovani e che, dopo 30 anni di lotta, otterrà l’indipendenza dell’Eritrea.
Parallelamente alla trama principale, grazie agli studi di medicina che i due amici frequentano, ci è possibile un godibilissimo excursus fra i diversi metodi terapeutici e le piante medicinali reperibili sul luogo. Hakim, tabib e debterà sono tre figure importanti nella cultura abissina. L’hakim (che dà il titolo al romanzo) è il medico come lo intendiamo noi, quello che si è laureato all’università e si affida alla scienza moderna. Il tabib è il medico tradizionale, che cura i suoi pazienti con erbe e sostanze ricavate dalla natura, in molti casi uguali o simili a quelle utilizzate dagli hakim. Basti pensare che da secoli in Abissinia si pratica la vaiolizzazione, si conosce una cura per la malaria, si usa il mercurio per la sifilide e si pratica una vera e propria psicoterapia. Il debterà, infine, è lo stregone che basa la sua riuscita sulla superstizione, sulla suggestione e su qualche provvidenziale colpo di fortuna.
Grazie all’ottima conoscenza del luogo, l’autore ci presenta la natura maestosa, terribile o esuberante della costa, del deserto e dell’altopiano e descrive accuratamente piante e animali, tanto da suscitare il desiderio di vedere di persona.
A questo si aggiunge un panorama a tutto tondo su quelle terre (non solo Eritrea, ma anche Etiopia) che comprende richiami di storia antica, note di storia dell’arte, tradizioni dei popoli abissini come i Cunama e cenni di storia contemporanea del Corno d’Africa. Molte le leggende ed i libri antichi citati (uno per tutti: “I segreti di Salomone” nell’antica lingua gheez, con i segreti della medicina tradizionale dei tabib), molti i cenni alle novelle abissine che presentano notevoli somiglianze con quelle europee, tanto da portare a domandarsi per quale via Esopo o i miti greci siano potuti giungere in Abissinia.
Nel libro emerge anche la situazione sociale nell’Eritrea abitata dagli italiani e colpisce la diffidenza per i meticci, condivisa da bianchi e da neri: Misan, amata invano da Marco, è meticcia e cerca in tutti i modi di uniformarsi agli altri eritrei e di far dimenticare la sua provenienza.
E’ sicuramente un romanzo con forti tratti autobiografici (Niky Di Paolo, come Marco, è nato in Eritrea, si è laureato in medicina ed ha dovuto a malincuore trasferirsi in Italia) e mostra la cospicua e dotta conoscenza delle materie esposte. E’ una piacevole lettura per tutti, ma può essere apprezzato particolarmente da chi ha già nel cuore i luoghi descritti dall’autore (che, ricordo, ha un interessantissimo sito sul Corno d’Africa: www.ilcornodafrica.it)
Mirella Pron
|
|
|
| Tullio Bazzanella in Etiopia - una vita di lavoro 1936-1978 |
| Chiara Bazzanella - Prospettiva editrice |
|
Che un saggio storico per una tesi di laurea possa essere letto come un racconto, coinvolgente e ricco di colpi di scena, è già un buon motivo per acquistare questo libro, tanto più che, se fosse stato scritto sotto forma di romanzo, avrebbe avuto una buona riuscita, ma avrebbe perso la connotazione di documento, che è ancora più interessante.
Tullio Bazzanella, nato nel 1905 in Trentino, era una persona normale, un giovanotto che, come tutti, desiderava trovare la propria strada. Aveva iniziato come apprendista falegname, mestiere rivelatosi poi la sua carta vincente, aveva poi continuato come operaio in una ditta italiana in Albania, e di lì, cominciata la guerra in Etiopia, si era arruolato nella Legione Parini che riuniva i volontari italiani provenienti dall’estero.
Da quel momento, la storia dell’uomo comune Bazzanella si interseca con la storia d’Etiopia e d’Italia.
La Legione ebbe la soddisfazione di entrare per prima nella città di Dire Daua, ma partecipò solo marginalmente alla battaglia precedente perché le fu preferito un battaglione arabo-somalo, più preparato ed efficiente. Tullio ebbe quindi la fortuna di passare indenne attraverso le vicende della guerra e fu uno dei pochi soldati che decisero di fermarsi in Etiopia dopo il conflitto, anche perché le sue competenze di falegname ben si adattavano alla grande disponibilità di legname del Paese. Si stabilì dunque nella regione dei Giam Giam, dirigendo una segheria alle dipendenze dello svizzero Evalet, e nel 1939, sposatosi per procura, si fece raggiungere dalla moglie Maria. Con l’entrata dell’Italia nella seconda guerra mondiale, anche Tullio venne richiamato alle armi per contrastare gli inglesi che subito si erano introdotti in Etiopia a dare man forte al popolo etiopico, ma anche questa volta la fortuna fu dalla sua parte e fu arruolato nella Milizia Forestale a pochi chilometri da casa sua. La conquista di Addis Abeba da parte degli inglesi provocò lo sbandamento e la fuga dei soldati italiani, nel tentativo di sottrarsi al campo di prigionia. Rinnegato con cattiveria dal suo datore di lavoro, Tullio, con Maria e il neonato Giuliano, fu confinato dagli inglesi in un quartiere, insieme a tutti gli italiani che attendevano di essere rimpatriati o, se militari, destinati a un campo di concentramento. Grazie alle sue doti umane e alla simpatia che aveva suscitato nella popolazione locale, non solo Tullio venne sottratto alla deportazione inglese dagli stessi etiopici che lo nascondevano a turno nelle proprie case durante il giorno, ma riuscì anche a procurarsi sempre latte e cibo per il figlioletto e per gli altri bambini italiani. Hailè Selassiè rientrò nella capitale il 5 maggio del 1941 e immediatamente tenne un discorso distensivo e conciliante che invitava la popolazione a non vendicarsi degli italiani. Desiderava infatti che i civili italiani restassero, sia per questioni economiche, sia per svincolarsi al più presto dalla pesante influenza inglese. Gli inglesi concessero solo 500 autorizzazioni a rimanere: un gran numero di italiani si diede alla clandestinità, ma non fu la sorte della famiglia Bazzanella che poté godere di uno dei permessi, rilasciato a Maria, nel frattempo impiegata nella gestione di un albergo. L’aspirazione di costruirsi un futuro sereno nell’Africa Orientale si consolidò nei decenni successivi, che Tullio trascorse alle dipendenze della Ethiopian Wood Works di proprietà dell’italiano Casati, come direttore della segheria. Vengono descritte le migliorie apportate alla produzione, la costruzione di strade e ponti, l’espansione dell’azienda ed i rapporti con le autorità e con la famiglia reale: tutti ambiti in cui Tullio ebbe un ruolo significativo. La vita della famigliola scorreva tranquilla, fra la scuola frequentata da Giuliano ad Asmara, il lavoro, le amicizie, l’interesse dei media italiani per i connazionali abitanti in una terra lontana che sentivano propria. L’Etiopia era per loro una seconda patria ma la Storia li costrinse alla fine ad abbandonarla. Il colpo di stato del 1974, la morte del vecchio imperatore e l’instaurarsi della dittatura comunista di Menghistù, infatti, portarono a una politica fortemente ostile agli stranieri e tesa alla nazionalizzazione delle proprietà private, cosicché Tullio fu obbligato dalle circostanze a lasciare definitivamente l’Etiopia nel 1978. Mantenne contatti e una fitta corrispondenza con gli amici e i collaboratori rimasti in Etiopia, cercando di aiutarli anche economicamente, ma non riuscì ad assistere alla fine di Menghistù perché morì nel 1989.
Per brevità, metto in risalto solo alcuni degli spunti che offre questo saggio, che consiglio vivamente di leggere.
Le vicende di Tullio si inquadrano nelle speranze dei colonizzatori, nella ricerca di “un posto al sole” dove metter radici: Tullio va in Etiopia spinto dal desiderio di dare una svolta alla propria vita, la scusa della guerra è solo il modo più veloce per attuare questo cambiamento. In realtà il suo desiderio profondo è quello di costruire qualcosa, il suo approccio alla cultura e alle persone indigene è assolutamente sereno e disponibile alla conoscenza ed è ricambiato dagli etiopici con lo stesso rispetto, come testimoniano, ad esempio, le lettere che gli scrivono i suoi operai quando si deve allontanare per qualche motivo.
Il gran numero di personaggi autentici che si incontrano nel saggio è utile a dare un quadro esauriente della Storia: alcuni sono personaggi minori (come il piccolo balilla Remo che scrive lettere di incoraggiamento, incolpevolmente piene di retorica e di pregiudizi, al soldato Tullio), altri sono personaggi noti che entrano marginalmente in contatto con i protagonisti (come il dottor Edoardo Borra che aiuta Maria nel parto, o il principe ereditario Asfa Wossen in visita alla segheria).
Corredato di fotografie e interessanti documenti, nonché di lettere personali che mettono in luce il lato umano della Storia, è interessante particolarmente nell’ultima parte, dove affronta una fase (colpo di stato di Menghistù) poco considerata da noi, che siamo più interessati alla storia degli anni 30-40, ritenendo di avere in comune con l’Etiopia solo quel periodo. Ciò risulta specialmente dagli insufficienti rapporti con gli italiani emigrati e dalla sostanziale indifferenza (tranne qualche fallito tentativo del Governo) alla ingiusta perdita di tutti i loro beni. L’autrice è la nipote Chiara, che immette nel saggio non solo una notevole preparazione, ma anche la commossa partecipazione alle vicende di un nonno molto amato, da cui ha ascoltato i racconti sull’Etiopia, terra che fa parte della vita di famiglia, con i profumi, i sapori e i suoni conosciuti fin da piccola.
|
|
|
|
Moyale |
|
di Rudi Cassini - edizioni Terra Ferma |
|
Moyale è un villaggio etiopico al confine con il Kenia: solo un corso d’acqua, secco per la maggior parte del tempo, lo separa dal suo omologo keniota. È un microcosmo in cui accadono cose semplici e insieme straordinarie, che ricorda il contesto scalcagnato di alcuni romanzi di Steinbeck, come “Pian della Tortilla” o “Quel fantastico giovedì”, ambientati dalla parte opposta del mondo ma popolati dalle stesse persone desolate, fantasiose e piene di dignità. La colonna portante è il diario di Rudi Cassini, veterinario della LVIA, ong piemontese che fra i suoi progetti di cooperazione ha anche la realizzazione di opere idriche per migliorare la vita delle persone e degli animali da cui esse dipendono strettamente. Alla sua voce, che spazia dalle riflessioni personali del diario agli intermezzi di poesie, dalle lettere a un’amica alle considerazioni sulla cooperazione, dalle minuziose descrizioni del paesaggio alla nostalgia di casa, si aggiunge quella di un abitante di Moyale, Nega, che sollecitato da Cassini racconta la storia del villaggio con disarmante lucidità. È un libro al contempo lieve e sostanzioso, in cui la descrizione della vita africana di un europeo (con il sottofondo dei cantautori italiani) fa riflettere: si legge velocemente, ma si è spinti a tornare sulle pagine lette per capire meglio. Le difficoltà burocratiche che intralciano la cooperazione, impedendole di raggiungere in pieno i suoi destinatari, sono solo una delle molte facce della realtà, che comprende anche le faide sanguinose fra etnie diverse, gli estenuanti passaggi di frontiera, la comunicazione gestuale con il custode musulmano, la natura commovente e spietata dell’Africa rurale, la compagnia teatrale di Moyale e la determinazione dei suoi componenti che “vogliono essere artisti”. Cassini non pontifica, anche se sull’argomento ha molta più esperienza dei suoi lettori: pur esprimendo, quando è il caso, le sue posizioni, racconta con semplicità, sempre interrogandosi e mettendosi in dubbio. Diverse cartine, disegnate a mano per far comprendere meglio posizioni e spostamenti, sono un’aggiunta gentile a questo bel libretto il cui acquisto contribuisce a sostenere il progetto LVIA a Moyale.
|
|
|
|
Mentuab, amore abissino in tre gradini del tempo |
|
di Niky Di Paolo – edizioni Memoria |
|
Mentuab era una regina etiopica vissuta a Gondar nel 1700. Giovanissima vedova del terribile Bacaffà, gli successe al posto del figlio, troppo piccolo per regnare. Il suo lungo regno fu caratterizzato da pace e benessere e ciò fa di lei un esempio di saggezza e di lungimiranza. Era ricca di intelligenza, garbo, notevoli capacità artistiche, cultura e anche di una straordinaria e duratura bellezza, testimoniata dai contemporanei, compreso l’esploratore scozzese James Bruce, console d’Inghilterra ad Algeri, che era andato in Etiopia alla scoperta delle sorgenti del Nilo, il quale la incontrò quando era ormai oltre la sessantina e ne rimase talmente affascinato da parlarne a lungo nei suoi diari. Il romanzo si apre ai giorni nostri, quando l’orefice quarantenne Fabio Leodandi, in crisi sentimentale, acquista un cascinale in Toscana e trova, dietro un tramezzo, i diari del figlio degli antichi proprietari, Pietro Tamburi, ufficiale dell’esercito al tempo dell’invasione dell’Etiopia nel 1936, conservati insieme a un rotolo finemente miniato e scritto in gheez (l’antica lingua letteraria dell’Etiopia) dalla regina Mentuab. Dapprima solo incuriosito e poi sempre più conquistato sia dal mistero racchiuso nel rotolo, sia dalle malinconiche vicende di Pietro, di cui si sono perse le tracce dopo la deportazione in Germania, Fabio parte per l’Etiopia, seguendo, dunque, una doppia traccia. I capitoli si alternano, narrando le storie d’amore “in tre gradini del tempo”: quello segreto di Mentuab per Iassu, semplice capo delle guardie; quello di Pietro per la moglie etiopica Zion, ostacolato dalle vicende della guerra; quello incerto di Fabio per Fulvia, la fidanzata che lo ha lasciato e per Almaz, la giovane informatica eritrea, conosciuta per caso in aereo, che lo accompagna nelle sue ricerche. La vicenda è ben narrata e scorrevole, nonostante la complicazione del continuo salto di tempo, anzi è proprio il differente punto di vista sullo stesso luogo visitato in tre epoche diverse a costituire uno dei pregi del romanzo. L’espediente del ritrovamento del diario, pur essendo uno dei più comuni, qui è molto efficace e non banale anche per la presenza del rotolo di Mentuab. Le scritte enigmatiche che accompagnano le miniature del rotolo sono infatti una delle chiavi del romanzo, che alla fine svelerà un commovente segreto. Non sarà comunque l’unico colpo di scena in un finale certamente non scontato. Una delle colonne portanti della narrazione è “il viaggio”, non solo quello in tre gradini del tempo, come suggerisce il titolo. Tutti i protagonisti, infatti, si muovono continuamente: Mentuab scopre le meraviglie del suo regno affrontando i disagi dei percorsi attraverso l’altopiano; l’approccio di Pietro all’Etiopia è reso con la lunghezza del viaggio in nave e con il progressivo avvicinarsi ad una realtà sconosciuta; Fabio si sposta dall’Italia all’Inghilterra e nell’Etiopia moderna inizialmente con la velocità che contraddistingue il nostro modo di vivere, poi con la lentezza riflessiva e appagata che l’Africa gli suggerisce. Il viaggio è anche metaforico e significa per tutti i personaggi il raggiungimento della conoscenza: Mentuab fin da bambina è desiderosa di imparare e rimane vivace e curiosa fino alla vecchiaia, nonostante le disgrazie della vita, come risulta dall’incontro con Bruce; Pietro parte alla scoperta di se stesso e la sua trasformazione sarà una sorpresa anche per il lettore; il viaggio di Fabio sulle tracce di Mentuab e di Pietro è in realtà il tentativo di dare un senso alla vita e all’amore. Anche il lettore godrà di un suo personalissimo viaggio, attraverso i luoghi, gli odori, le situazioni, i nomi, i colori, gli animali e i costumi dell’Etiopia, resi con grande freschezza e attenzione. L’autore, infatti, è un profondo conoscitore dell’Etiopia in ogni suo aspetto, essendo nato e vissuto in Eritrea fino alla fine degli anni 60: lo si intuisce anche senza saperlo poiché le descrizioni, i commenti e le citazioni sono puntuali e assolutamente attendibili. Deve aver condotto anche un’approfondita ricerca storica, che arriva fino ai particolari del paesaggio e degli interventi operati dall’uomo, sia sull’Etiopia del 1700, sia su quella più recente della nostra occupazione. In conclusione, consiglio questo libro sia a chi è interessato all’Etiopia, sia a chi desidera solo impiegare proficuamente qualche serata con un bel romanzo. Segnalo inoltre che Niky Di Paolo è uno dei fondatori del sito www.ilcornodafrica.it , autentica miniera di informazioni sull’Etiopia e l’Eritrea.
|
|
|
Vai e vivraidi Rahu Mihaileanu con Alain Dugrand, ed. Feltrinelli 2005
|
|
Da questo romanzo l’autore, che è regista cinematografico, ha tratto anche un bel film, uscito nelle sale italiane qualche mese fa. Narra la storia di Menghistu, terzogenito di una famiglia cristiana etiopica decimata dalla fame e dalle guerre, che, alla metà degli anni 80, giunge con la mamma e il fratello maggiore in un campo profughi del Sudan meridionale. Anche il fratello muore in una rissa fra disperati ed è intuibile che quella sarà la fine della maggioranza dei profughi. Nello stesso campo si trova Worknesh con il piccolo Shlomo, coetaneo di Menghistu: sono falasha, ebrei etiopici, sfuggiti alla carestia ed alle persecuzioni, rifugiati in Sudan, paese musulmano, sotto mentite spoglie. Shlomo muore di febbre e di stenti poche ore prima che si concretizzi il piano di Israele per salvare e portare nella Terra promessa gli ebrei etiopici. Le due madri si intendono con gli sguardi e la cristiana Kidane affida all’ebrea il proprio figlio che solo così potrà avere la possibilità di sopravvivere. Da quel momento Menghistu diventa Shlomo e la sua vita prosegue su un doppio binario: da una parte il rimpianto misto a senso di colpa verso la mamma lasciata in Sudan, nonché la consapevolezza dell’inganno su cui si basa la sua esistenza e il terrore di essere scoperto; dall’altra parte le difficili vicissitudini di un ragazzino nero, sradicato dalla sua cultura, colpito da un nuovo lutto (la morte della mamma ebrea), adottato da una famiglia amorevole e aperta, soggetto a discriminazioni razziali, impegnato nello studio anche della religione, rifiutato dalla famiglia della ragazza che ama e che comunque sposa. Soffocato dalla menzogna originaria della sua esistenza, riconosciuto da qualcuno che lo aveva incontrato nella vita precedente, Shlomo alla fine confessa alla propria famiglia e alla moglie la sua difficile condizione di cristiano cammuffato da ebreo e, con il sollievo per la loro reazione comprensiva, trova la forza di andare a esercitare la professione di medico nello stesso campo profughi della sua infanzia. Lì, in modo possibile forse solo nei romanzi, ma comunque toccante, riconosce in una vecchia distrutta dagli stenti la mamma etiopica. Il romanzo si conclude con il grido straziante della donna che finalmente dà libero sfogo all’angoscia accumulata negli anni. È un libro intenso e commovente che solleva innumerevoli questioni e sollecita molte riflessioni. È interessante dal punto di vista storico, avendo l’autore fatto numerose ricerche sulla vita dei falasha e soprattutto sul preciso avvenimento dell’intervento di Israele e delle difficili relazioni fra stati nemici. È resa bene anche la vita quotidiana, sia quella in Israele, contraddistinta da un forte senso di appartenenza ma anche da posizioni interne assai diverse, sia quella in Etiopia, evocata nei ricordi di Shlomo con i richiami alla mucca, alla luna, alla natura, al bene prezioso dell’acqua che non si può sciupare. Da un’ottica sociologica, fanno riflettere le discriminazioni razziali e religiose, sia quelle a cui sono sottoposti i falasha in Etiopia e, peggio ancora, in Sudan, sia quelle di cui sono oggetto in Israele, perché neri di pelle e sospettati di non essere puri dal punto di vista religioso. Anche la psicologia ha il suo terreno di indagine nelle esperienze traumatiche che bloccano per certi aspetti la vita, nella solitudine disperata, nell’abbandono vissuto come propria colpa che sono tratti comuni ai bambini adottati. A questo proposito, una ventata di ottimismo è data dalla disponibilità della famiglia adottiva che accoglie, sostiene e comprende totalmente Shlomo, in ogni fase della sua difficile vita, permettendogli di conquistare la serenità. Infine, il fatto che Shlomo torni nel campo profughi dopo almeno vent’anni e sua madre sia ancora là pone alle nostre tranquille coscienze una domanda inquietante: è un destino ineluttabile che tante persone siano profughe per sempre o queste situazioni possono essere cambiate?
|
|
|
|
Un viaggiatore in braghe di tela di Felice Pozzo, CDA & Vivalda editori, 2003
Si tratta della vita avventurosa di Augusto Franzoj (già riassunta da Manlio Bonati nella scheda a lui dedicata su questo stesso sito), un arrogante giornalista che incarna uno dei miti del suo tempo: il viaggiatore audace ed esagerato ma anche galantuomo che sfida la natura selvaggia e l’incomprensione degli uomini, indigeni o connazionali che siano, per un fine nobile (in questo caso il recupero dei resti dell’esploratore Chiarini) e che conclude la propria esistenza nello stesso modo violento in cui l’ha condotta. Le vicissitudini del Nostro, che risulta nel complesso simpatico, sono trascinanti, sempre sopra le righe e ricche di colpi di scena. La naturalezza con la quale affronta i pericoli denota più faccia tosta che coraggio e la testardaggine con la quale si imbarca in nuove avventure, il cui scopo principale è il riconoscimento del proprio valore, a riscatto di chissà quali mancanze, suscita perfino una certa compassione. L’uomo è nello stesso tempo generoso e tronfio, ingenuo ed egocentrico e l’autore rende bene queste contraddizioni con l’ausilio di numerosi documenti dell’epoca. E’ ben descritto l’ambiente dell’Etiopia inesplorata, degli “scium” corrotti o cordiali, delle guide infide o ingenue, degli schiavi, dei gesti di amicizia inaspettati, dei sotterfugi necessari per conquistare la simpatia di chi può essere utile. Le avventure di Franzoj vengono messe in relazione alla storia degli altri esploratori del 19° secolo e delle loro spedizioni fallite o riuscite e si intrecciano con le tentazioni coloniali dell’Italia fra personaggi storici di notevole importanza e manovre sotterranee di oscuri politici. Molti collegamenti sono anche fatti fra gli scritti del Franzoj e altre opere letterarie dell’epoca, articoli di giornale, epistolari di persone famose. A questo proposito, un altro lato interessante del libro è che l’autore è un cultore ed uno studioso di Emilio Salgari, il quale fa capolino di persona fra gli avvenimenti narrati. In una sola opera troviamo dunque un libro di viaggio, uno di avventure, una biografia ed un saggio storico-letterario, peraltro interessanti e scritti in maniera vivace. Soldi e tempo ben spesi.
|
|
|
|
Etiopia - viaggio nella storia e nelle leggende di Rossella Alberti, edizione Campanotto – Rifili, 2003
E’ un librettino tascabile di un’ottantina di pagine, corredato di disegni dell’autrice, ricalcati da quelli di pergamene antiche o da fotografie delle guide turistiche. Ha una serie di lati negativi ed uno solo positivo, che però vale la spesa di 9 euro ed è il motivo per cui ve lo consiglio, specialmente se vi accostate per la prima volta al mistero dell’Etiopia. Il primo lato negativo è puramente formale: una punteggiatura casuale che spezza il ritmo delle frasi, spesso impedisce di comprenderne subito il senso ed è, per questo, assolutamente irritante. Sarebbe stata preferibile una correzione delle bozze più scrupolosa ed anche un’impaginazione meno artigianale e una presentazione nella quarta di copertina più accurata. Gli altri lati negativi sono invece sostanziali: numerose imprecisioni e approssimazioni deludono il lettore che conosce la materia e gli fanno sospettare inesattezze anche nelle notizie che non conosceva. Tre esempi: l’Etiopia conquistata dall’Italia nel 1939 (lo fu nel 36) ed “abbandonata” nel 1940 (fu perduta nel 41), le imbarcazioni del lago Tana in giunco (sono in papiro come quelle dell’antico Egitto), il tef che serve a fare il pane (serve invece a fare l’injera che è completamente diversa dal pane). Non è quindi un trattato da prendere alla lettera e per un viaggio vero è consigliabile munirsi di una vera guida turistica, ma il riscatto di questo piccolo libro sta nella freschezza e nella naturalezza con cui l’autrice mescola le notizie turistiche con le leggende nella parte dedicata agli itinerari, nonché nella delicatezza con la quale descrive le opere artistiche del Paese. Se il viaggio è destinato a rimanere immaginario, con questo libro si può scatenare la fantasia, sognando paesaggi mai visti e percorsi emozionanti. Può però essere consigliabile anche se si intende partire davvero, accanto a manuali più completi e pratici, per non eliminare la dimensione fantastica e lo stupore della scoperta.
|
|
La letteratura etiopica di Enrico Cerulli, edizioni Sansoni 1968 reperibile nelle librerie che trattano i “remainders” o in biblioteca
Il libro che vi consiglio questa volta può essere affrontato a due livelli. Se avete una notevole cultura letteraria, potrete confrontare i testi etiopici con quelli europei degli stessi periodi, collegare letteratura e storia, approfondire basandovi sulle note e farvi sorprendere da un autore che, per spiegare bene un passaggio, va al British Museum, si fa consegnare un “codice” inedito e traduce direttamente dal Gheez (la lingua antica degli etiopi). Noi persone normali, però, non dobbiamo scoraggiarci: non si tratta di un mattone illeggibile o per il quale sia necessaria una cultura pazzesca. Le cose che occorrono sono: amore per l’Etiopia in tutti i suoi aspetti, una conoscenza anche solo superficiale della storia di quel Paese, una matita per segnare i passaggi da rileggere con calma. Uno dei fili conduttori del libro è la storia etiopica, come la conosciamo dalle guide turistiche. Se abbiamo presente a grandi linee la leggenda di Salomone e della regina di Saba, la storia di Axum e della conversione al cristianesimo del re Ezana, di Lalibelà e delle chiese rupestri, dei re di Gondar, del riunificatore Teodoro, di Giovanni IV e Menelik II, possiamo ritrovare gli stessi soggetti, ma questa volta in originale. Per esempio, è del 1300 il famosissimo Chebra Neghèst (La Goria dei R) che è il libro in cui si trova il racconto di Salomone e della Regina di Saba, del loro figlio Menelik e dell’Arca dell’Alleanza portata da questi in Etiopia e tuttora conservata, secondo la leggenda, in una cappella della chiesa di Mariam Tsion ad Axum. E’ affascinante poter leggere direttamente dalla fonte una storia che è stata banalizzata dalle guide turistiche ma che invece presenta inaspettati risvolti poetici. Del periodo di Axum possiamo confrontare due iscrizioni del re Ezana, prima e dopo la conversione: è divertente come, quasi senza farsi notare, nella seconda opera egli sostituisca il nome e gli appellativi del dio Mahrem, al quale credeva prima di convertirsi, con il Dio unico dei cristiani, definendo già da allora la prudenza come tratto fondamentale della letteratura etiopica. Le solite guide turistiche ci hanno già informato delle api che si posarono su Lalibelà bambino o dei sogni che portarono il re a far costruire con l’aiuto degli angeli le famose chiese nella roccia, ma qui possiamo sapere senza intermediari come egli scelse la moglie per ordine divino o come la affidasse all’angelo Michele per andare in pellegrinaggio a Gerusalemme. Dei re di Gondar il più citato dalle guide è Fasiladès (quello della piscina vicino ai castelli merlati) che troviamo negli Atti della santa Wolatta Petros, una figura femminile coraggiosa e fiera che non esita nel prender decisioni a difesa della fede anche senza consultare il re. Il 19°e poi il 20° secolo vedono l’affermarsi delle lingue amarica e tigrina al posto dell’antico etiopico in opere storiche che ci parlano dei grandi imperatori precedenti ad Hailè Selassiè: fra tutti, è bello, sia per la tensione emotiva che trasmette, sia per la curiosità storica, il racconto della morte del tigrino Giovanni IV che preferisce morire sul campo di battaglia contro un nemico esterno piuttosto che essere battuto dal suo antagonista interno, il futuro Menelik II. La lettura del libro ci porta anche ad ampliare le nostre conoscenze storiche con le cronache delle guerre condotte, circa nel 1300, da Amda Tsion, uno dei primi re dopo che Yekuno Amlak ebbe ripristinato la dinastia dei Salomonidi, presentato dai suoi contemporanei come leale e coraggioso. A solo cento anni di distanza, però, durante l’era del re Zara Yacob, il valoroso Amda Tsion viene mostrato come un re peccatore e indegno, persecutore di cinque santi monaci con i quali si accendono continui dissidi ed a cui sono dedicate ampie biografie. Nel capitolo ottavo, dedicato alle invasioni che l’Etiopia subì nel 1500, troviamo la storia dell’invasione dei Galla, fieri e sanguinari, e una lucida, desolata e a tratti comica riflessione sulla superiorità bellica degli invasori, che si dedicano tutti alla guerra, mentre gli etiopici si dividono in dieci classi di cui nove rifiutano categoricamente di combattere con le più diverse motivazioni. Con l’invasione musulmana, la letteratura etiopica si arricchisce di Storie scritte da ambedue le parti, cristiana e islamica: è quindi interessante osservare lo stesso periodo da punti di vista opposti, anche perché la lettura è agevole, ricca di particolari e in certi punti divertente. Un’altra possibile chiave di lettura sono le opere religiose. Un posto particolare hanno le numerose opere riferite alla Madonna, fra cui spicca per importanza il Libro Etiopico dei Miracoli di Maria, che ha un’origine francese ma si è via via arricchito di contributi europei e medio orientali, in una specie di viaggio letterario nella fantasia che termina in Etiopia circa nel 1400. I racconti ufficialmente riconosciuti dalla chiesa etiopica sono 33, ma fortunatamente, a causa dell’indipendenza di cui godevano i singoli monasteri, ne sono arrivati a noi molti altri. Ancora, notevoli sono gli Atti dei fondatori dei maggiori monasteri, fra cui la parte più divertente si trova negli Atti di Giovanni l’Orientale, verso la fine del quarto capitolo, in cui facoceri, iene e istrici si alleano con il drago contro San Giovanni che infine li sconfigge in maniera singolare. Curiosa, alla fine del sesto capitolo, è la lettera dell’abate Nicodemo al Papa Eugenio IV in occasione di una missione etiopica al Concilio di Firenze: il povero abate deve contemporaneamente ribadire l’autorità del re Zara Yacob e non dispiacere al Papa, difendere la dottrina monofisita e mantenere buoni rapporti con gli occidentali. Ci sono anche opere religiose scritte al tempo dell’invasione musulmana, da entrambe le parti, allo scopo di mostrare la superiorità della propria religione e difenderla da defezioni spesso dettate dalla convenienza. Bizzarra (e già sbagliata di parecchi secoli) la profezia del monaco Enbakom che predice alla religione musulmana 1000 anni di esistenza (e soltanto grazie ai peccati dei cristiani, perché altrimenti sarebbero stati solo 700). Anche gli eretici danno il loro contributo, magari mascherandosi da difensori della religione ufficiale, ed il “Viaggio alla ricerca della conoscenza di Dio” dei Micaeliti, nel capitolo decimo, è un capolavoro di ambiguità per come cerca di far passare l’eresia fra le pieghe del monofisismo etiopico, ma a noi interessa di più la forma del racconto che assomiglia alle tipiche fiabe africane e lo rende bellissimo. Concludendo, è un testo non facilissimo da leggere, ma presenta due innegabili vantaggi: uno, che Cerulli spiega bene anche i passaggi più impegnativi; due, che al contrario di un romanzo si possono saltare le parti difficili (particolarmente faticose le poesie con lo stile “Cera e oro” nel 10° capitolo) e magari tornarci alla fine del libro. Vi assicuro che sarà una lettura affascinante. Del resto, accanto alle opere di tradizione europea, perché non offrire ai nostri figli opere etiopiche, come quelle già citate o come il racconto della Madonna e del cane assetato del quinto capitolo? Senza contare le poesie, tra le quali vi segnalo: quella dedicata alla Crocifissione nel terzo capitolo, la poesia guerresca, scarna ma vigorosa, contro un mancato usurpatore del trono che si trova alla fine del capitolo settimo, e le "Effigi" del capitolo dieci che fanno le lodi di ciascuna parte del corpo del Santo che si vuole celebrare, partendo dalla testa fino ai piedi… Non perdetelo!
Avventura sul Nilo Azzurro di Rudigher Nehberg, edizioni TEA 2002
Vi segnalo due libri di viaggio sull’Etiopia, per certi versi simili, per altri molto diversi fra loro ma in ogni caso affascinanti. Il primo, “Avventura sul Nilo Azzurro” di Rudigher Nehberg, edizioni TEA, narra di tre tedeschi - un pasticcere (l’autore), uno studente e un cameraman – che organizzano un’impresa mai riuscita fino ad allora (siamo nel 1972): seguire il corso dell’Abbai, il leggendario Nilo Azzurro, dal lago Tana ai confini del Sudan. I preparativi sono lunghi e meticolosi, dalla costruzione di una barca “inaffondabile” ai corsi di sopravvivenza nei boschi, dall’allenamento a mangiare larve alle prove di navigazione su una diga dell’Elba. Dopo un primo tentativo fallito a causa di un albero che ostruisce il corso del fiume, i tre impavidi ci riprovano, pur sconsigliati da tutti, e fra mille peripezie riescono a portare a termine il loro progetto. E’ un racconto molto coinvolgente, ci si immedesima nei protagonisti e ad ogni ostacolo superato la sensazione è sempre quella di essere ancora in prima linea, aspettando il prossimo. Le descrizioni dei luoghi e degli animali sono molto interessanti. Un altro lato positivo sono le descrizioni degli indigeni, delle loro storie e delle loro usanze, sempre trattati, anche quando sono ostili e pericolosi, con il rispetto che si deve alle persone, e mai con quel tono di superiorità che spesso contraddistingue chi proviene dal nord del mondo.
In Etiopia con un mulo di Dervla Murphy, edizioni EDT 2000
Il secondo, “In Etiopia con un mulo” di Dervla Murphy, edizioni EDT, è il diario di una eccentrica irlandese che nel 1966 decide di viaggiare sull’altopiano percorrendo quella che le agenzie di viaggio chiamano “la rotta storica” ( che comprende Axum, Lalibelà, Gondar, il lago Tana, tanto per nominare alcuni dei luoghi che ci sono familiari). Solo che lei non si affida ad un tour operator ma alle sue gambe e a quelle del simpaticissimo mulo Jock. Con una forza ammirevole si arrampica su e giù per le ambe etiopiche e durante i tre mesi di viaggio sperimenta tutta la gamma di possibilità dei viaggi di avventura: la solitudine estrema e la confusione delle feste tipiche, la condivisione di un pasto frugale nei villaggi più sperduti e il terrore dell’assalto dei banditi, la visita formale alle personalità del luogo e l’ospitalità generosa su giacigli pieni di cimici, la gente che le chiede aiuto per le malattie e quella che le tira dietro i sassi. Tutto viene narrato con grande senso dell’umorismo, per cui la lettura, oltre che estremamente interessante, è anche divertente. Nelle descrizioni delle persone che incontra, l’autrice non si fa tentare né dal buonismo né dai pregiudizi, e rimane se stessa in ogni rapporto con gli altri, per cui la simpatia o l’antipatia che prova nei confronti di questo o quello sono genuine e non falsate dal timore di sembrare razzista o, al contrario, dalla pretesa di essere dalla parte della “civiltà”.
Le somiglianze fra i due libri sono: i luoghi (pur da due punti di vista diversi – sopra o sotto lo strapiombo – si parla pur sempre della nostra amata Etiopia e dei suoi paesaggi mozzafiato), l’approccio alle persone (caratterizzato da grande rispetto), il gusto della scoperta (come ricerca dell’altro e non come accentuazione delle differenze).
Le differenze: Nehberg privilegia, come da titolo, l’avventura e il libro dà un po’ l’idea del film d’azione; la Murphy dà più spazio alla contemplazione e alle riflessioni personali e il suo libro assomiglia di più a un misto fra documentario e racconto di formazione.
Dal ventre della iena di Nega Mezleika, edizioni Mondadori 2002
L’autore racconta la sua vita in Etiopia fino all’età di 25 anni quando ha lasciato definitivamente il Paese e, dopo l’Olanda, si è stabilito in Canada. Tutto il libro offre una lettura piacevole e interessante e la narrazione è permeata di un sottile umorismo. Si può dividere in due parti: nella prima è raccontata l’infanzia e la prima adolescenza dell’autore, durante l’impero di Hailè Selassiè. La sua famiglia era abbastanza benestante e il racconto si svolge nella città di Giggiga, ad est di Harar, fra episodi divertenti, tradizioni, favole tipiche, superstizioni. La vita scorre serena ed è appena toccata la condizione dei contadini servi della gleba contro la quale il giovane Negà e i suoi compagni di scuola si illudono di poter fare qualcosa, ottenendo soltanto di essere periodicamente arrestati e bastonati. Nella seconda parte irrompe improvvisamente la dura realtà: dopo il colpo di stato di Menghistù, l’adolescente Negà entra nella guerriglia, assiste alla morte dei suoi compagni, prova fame e dolore, poi rientra a casa dove scopre che anche il padre è stato giustiziato. Scoppia la guerra con la Somalia e la famiglia deve scappare da Giggiga, cercando di raggiungere la città di origine della mamma. Tutto d’un tratto, questa simpatica famiglia che abbiamo imparato a conoscere nelle pagine precedenti si trasforma in un disperato gruppo di profughi, in mezzo a centinaia di altri nella stessa condizione. La loro immagine si sovrappone a quella consueta dei telegiornali, dove siamo ormai abituati a vedere donne con lo sguardo fisso che tengono in braccio bambini allo stremo, circondate da uomini senza forze che nelle mani, invece di pane, stringono un inutile e assurdo fucile. Queste stesse persone non sono più semplici comparse ma sono la mamma di Negà, i suoi fratellini fra cui Henoch di 3 anni che sta morendo di fame e di asma, la donna traumatizzata che ha dovuto scegliere, fra 5, i soli 2 figli che potevano salire sul camion della salvezza e abbandonare gli altri. Fortunatamente riescono a raggiungere la meta, ma il ragazzo si rende conto che la sua vita è appesa a un filo e che chiunque potrebbe denunciarlo o giustiziarlo in mezzo alla strada. Si reca quindi ad Addis Abeba dove frequenta l’università sempre nel terrore di venir ucciso come ogni giorno capita a centinaia di persone innocenti. Trasferitosi per sicurezza in un’università periferica, studia ingegneria agraria. Dopo un anno viene chiamato a casa per la morte della madre, uccisa su un autobus da ribelli somali. Anche nei momenti più drammatici l’autore non perde l’ironia che lo accompagna dall’inizio del libro. Ne è la prova il racconto del funerale della mamma paragonato a quello dei personaggi più importanti: proprio per il sorriso che riesce a strapparci nonostante tutto, ci rende più vicine le cose che gli accadono. I 4 fratelli più piccoli vengono affidati alla sorella maggiore sposata; un’altra sorella, Almaz, ribelle e intelligente, va a vivere da sola e partorisce un figlio illegittimo; Negà, che provvede al mantenimento di tutti con l’impiego statale che ha ottenuto dopo la laurea, parte per andare a farle una lavata di capo, immaginandosi che la ragazza prometterà di mettere la testa a posto. Invece, e questa è una parte toccante specialmente per chi è genitore di bimbi etiopici, la trova sorridente col suo neonato, convinta che anche un figlio illegittimo sia una consolazione. Ottenuta infine una borsa di studio per l’Olanda, assiste da lontano alla tremenda carestia del 1984, quando gli ingenti aiuti inviati da tutto il mondo vengono sperperati da Menghistù, e, rendendosi conto che la dittatura non finirà così presto come lui si aspettava, decide di trasferirsi definitivamente in Canada. Solo dopo anni riuscirà ad avere notizie della famiglia e saprà che i 4 piccoli sono stati buttati fuori casa, che Henoch è stato raccolto dopo un anno per strada da un’associazione e poi affidato a un’altra sorella, che Almaz ha avuto altri due bimbi illegittimi. Così, la realtà dell’abbandono che ci tocca da vicino come genitori adottivi ci è presentata anche dall’altro punto di vista. Consiglio vivamente questo libro alle famiglie italo-etiopiche che vi troveranno molte cose familiari, già lette in altre occasioni o sentite dai propri figli, e molte cose nuove che contribuiranno a una conoscenza più approfondita di un Paese a cui siamo molto legati. Ma lo consiglio anche a tutti gli altri perché dopo tanti libri scritti da stranieri, seppure rispettosi e innamorati della cultura etiopica, si ha finalmente un punto di vista “interno” al quale purtroppo non siamo abituati, dato che gli scrittori africani, e specialmente etiopici, qui da noi non sono ancora conosciuti. |
|
|
|
|
Tutti i diritti letterari e fotografici riservati