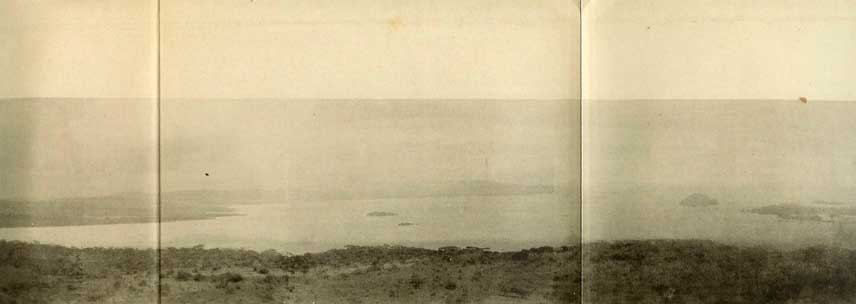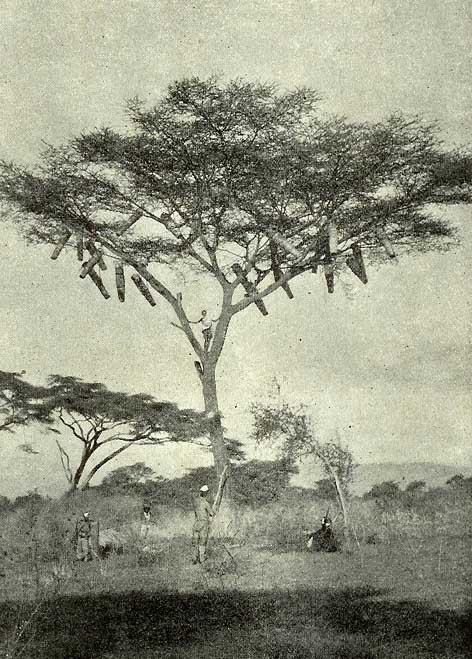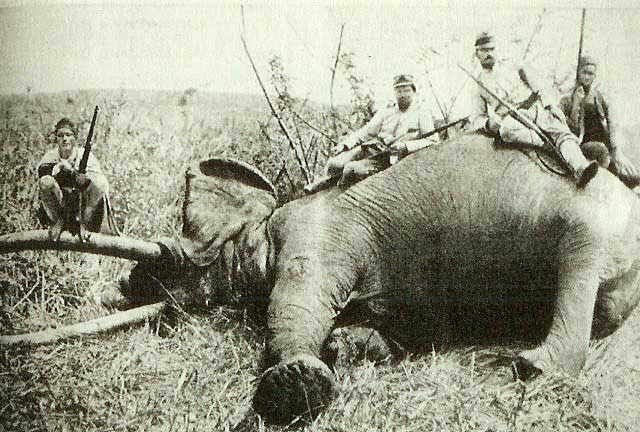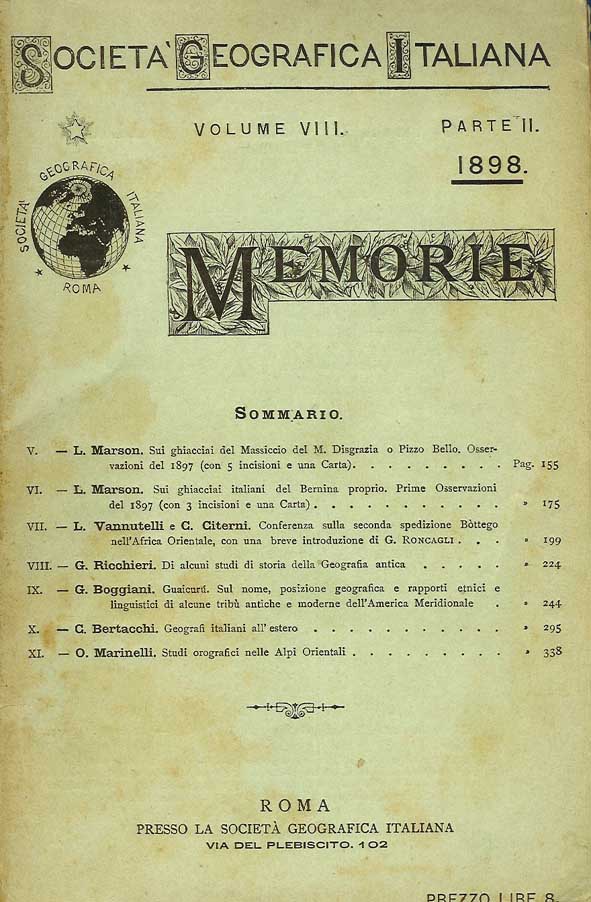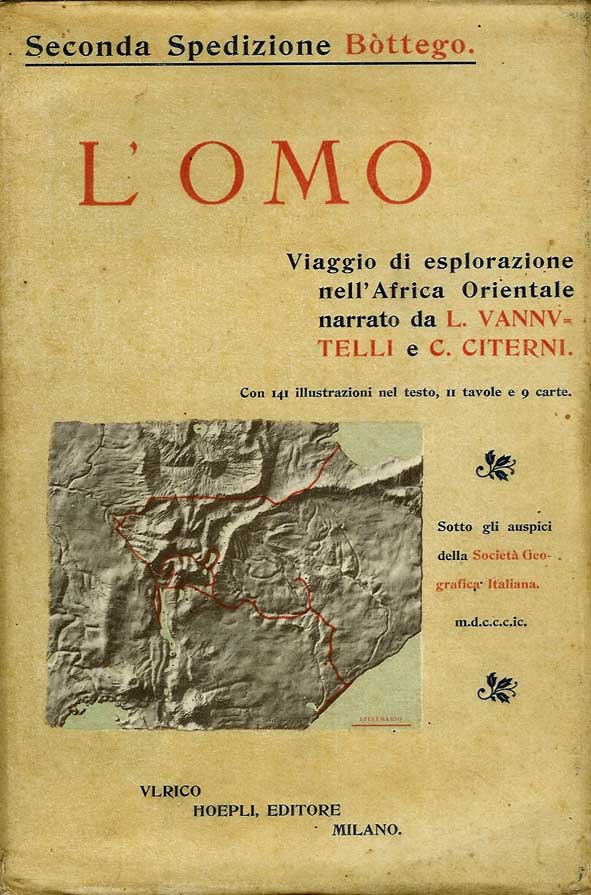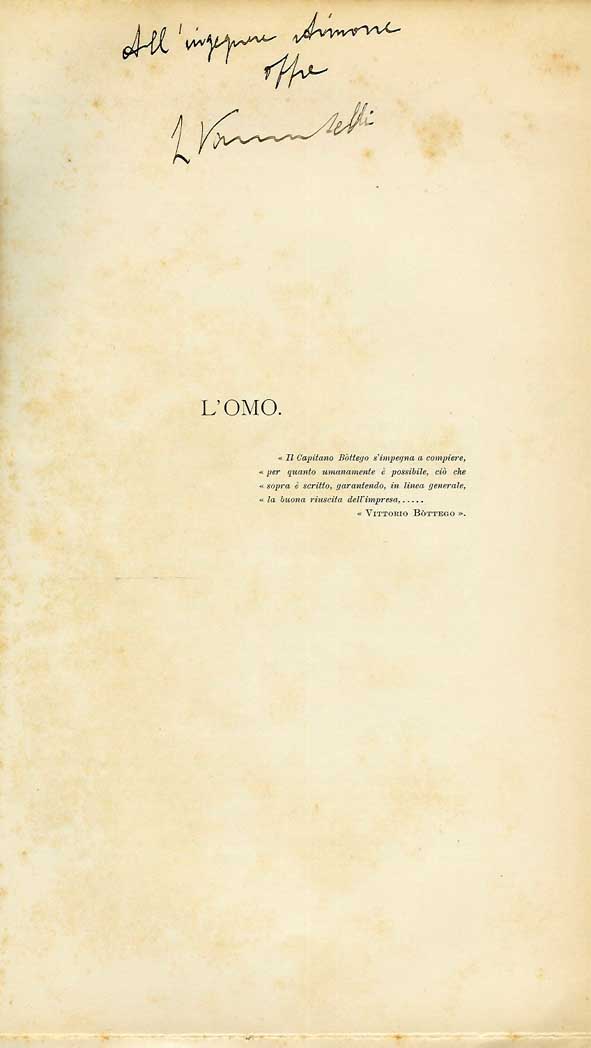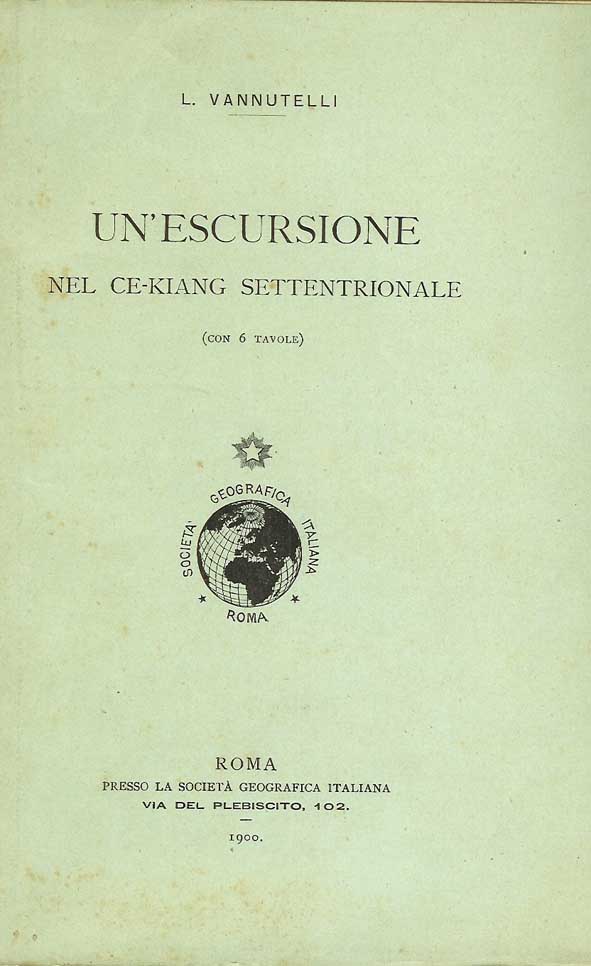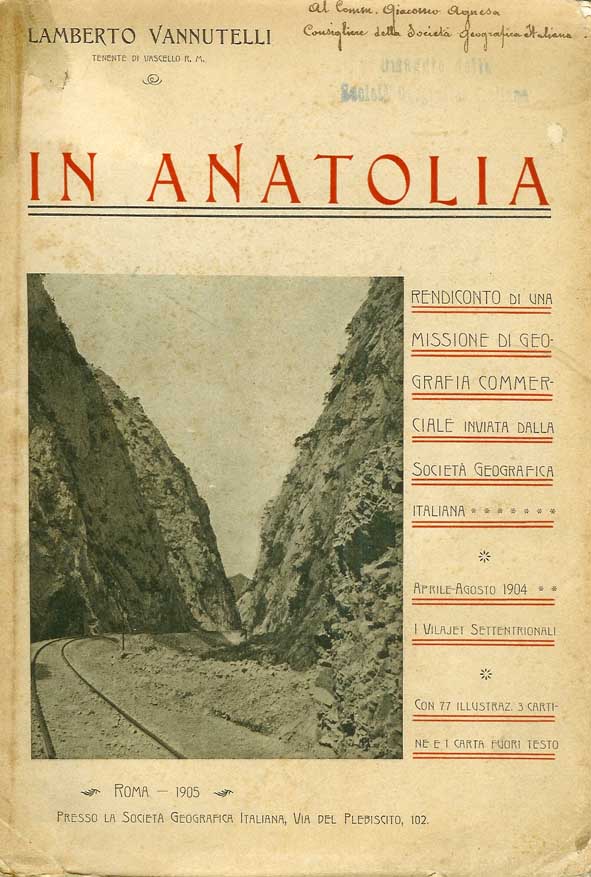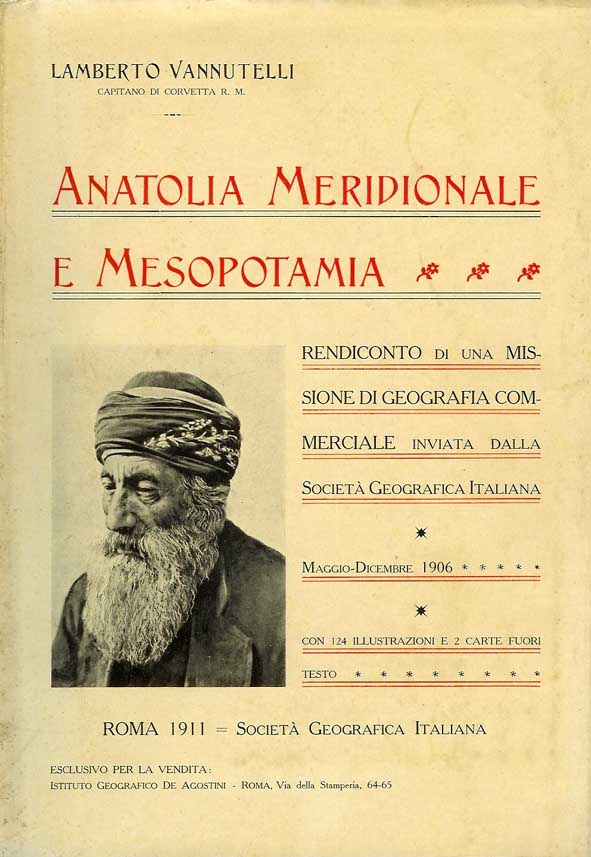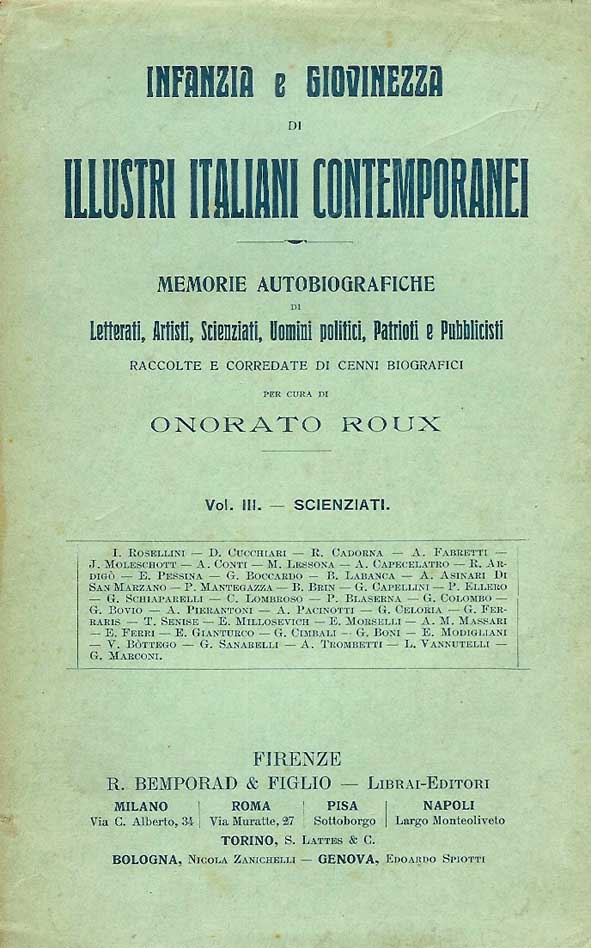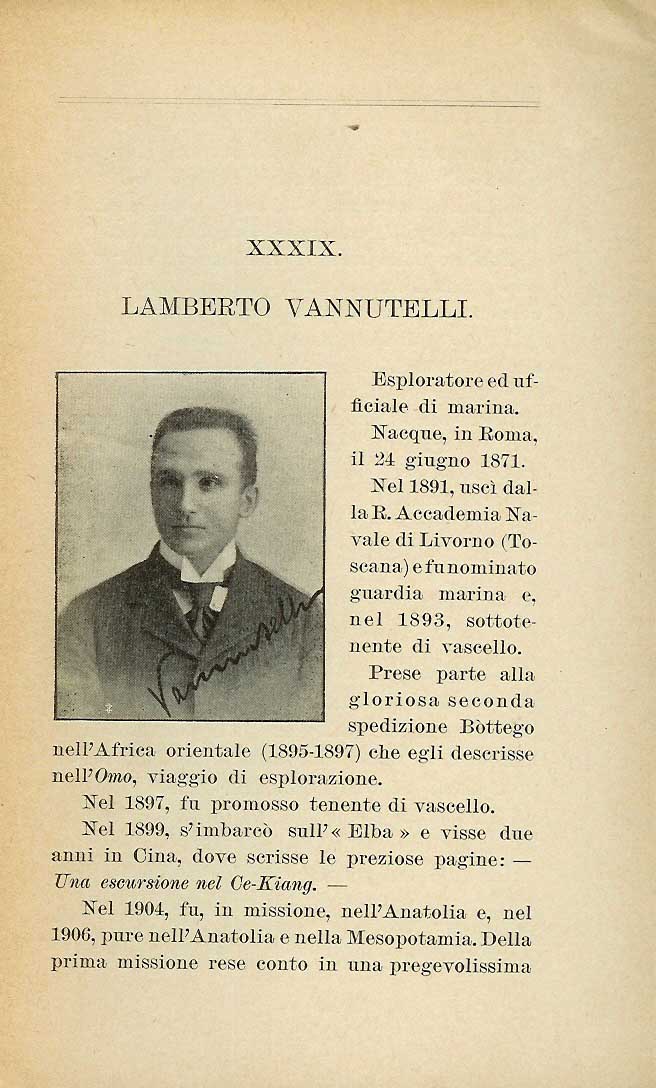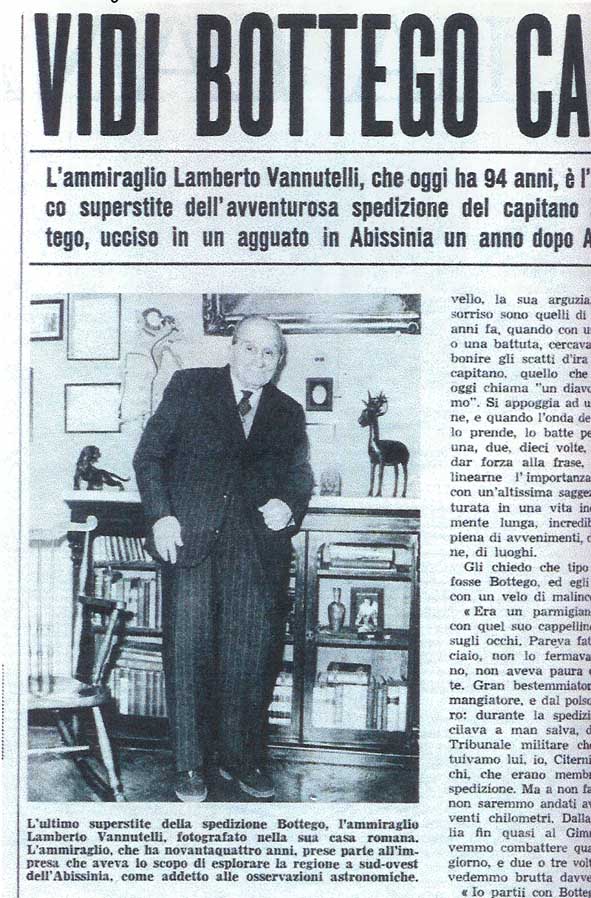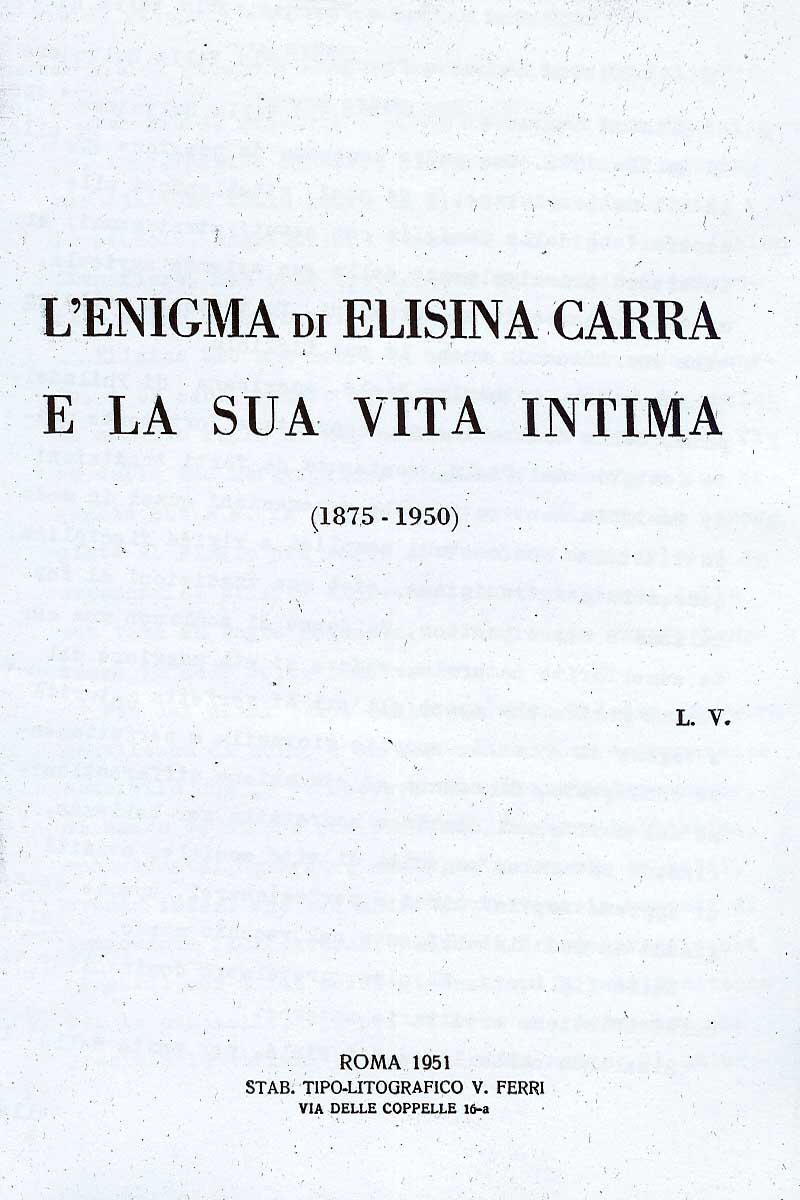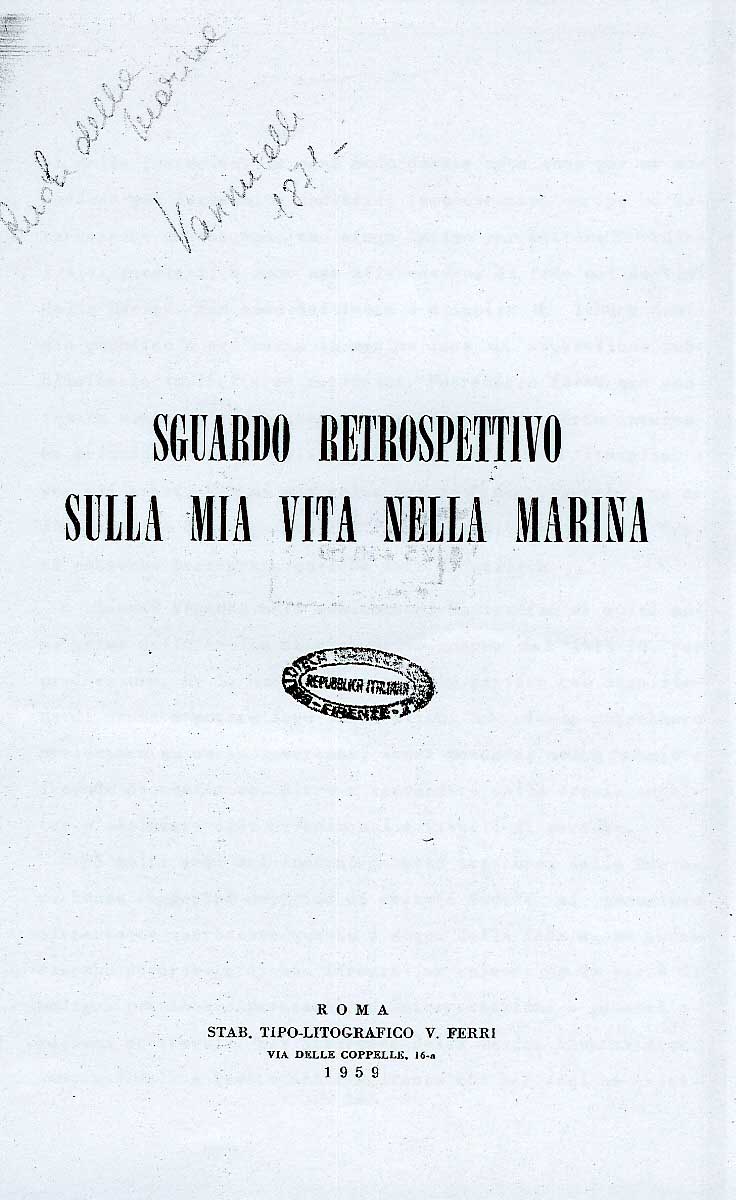|
Il 5 maggio 1895
dalla Regia Accademia Navale di Livorno il sottotenente di vascello
Lamberto Vannutelli scriveva al capitano d’artiglieria Vittorio
Bottego per chiedergli di accettarlo come componente della sua
seconda spedizione nell’Africa Orientale, adducendo tra le altre
cose il fatto di non essere «completamente nuovo dei viaggi in
Africa ». Infatti nel 1893, appena nominato sottotenente di
vascello, domandò ed ottenne di essere destinato sullo stazionario a
Massaua: “e così potei cominciare le mie prime esperienze africane
con brevi gite nella nostra colonia”.
Vannutelli era nato a Roma il 24 giugno 1871, da Ugolino Vannutelli
e da Adele Costa. Per i primi anni la sua educazione ed istruzione
“furono fatte completamente in casa; ma, poi, feci i primi tre anni
di ginnasio all’Istituto Massimo, alle Terme, ed un anno di
preparazione all’Accademia Navale all’Istituto Verger. (…) Ebbi
sempre una grande passione per la caccia e per la vita di campagna e
mostrai sempre molta disposizione per le scienze matematiche e in
modo speciale per la geografia e la conoscenza del mondo in
generale”.
Nel 1885
fu ammesso al primo corso della R. Accademia Navale di Livorno e ne
uscì guardiamarina nel 1891. Si distinse per l’amore allo studio
dell’Astronomia, “tanto che fui pure soprannominato l’astronomo”.
Dopo la parentesi in Eritrea, seguì il corso superiore di Livorno,
che terminò nel 1895.
Giovanissimo si era appassionato alla storia delle esplorazioni;
interesse scaturito per merito dei libri di Giulio Verne e del Mayne
Reid, le sue “letture preferite”, come scrisse in una lettera del 31
dicembre 1906 a Onorato Roux, curatore dell’importante quanto oggidì
raro volume Infanzia e giovinezza di illustri italiani
contemporanei. Memorie autobiografiche, volume III – Scienziati
(edito a Firenze da R. Bemporad & Figlio nel 1910). Naturale perciò
il suo accostamento verso il Bottego che due anni prima aveva
scoperto le sorgenti del fiume Giuba. In un primo tempo
l’esploratore parmigiano aveva prescelto un altro giovane ufficiale,
il guardiamarina Ugo Rua, ma un’accurata visita medica della
direzione del servizio sanitario del ministero della Marina aveva
riscontrato che il Rua era stato colpito precedentemente da una
malattia venerea, con conseguente sua inidoneità. Ovvia fu la scelta
del Vannutelli non soltanto perché occorreva per la spedizione un
valido osservatore dei fenomeni atmosferici, ma anche in quanto
«immune da infezione sifilitica e da malattie organiche degli
apparati respiratorio e circolatorio» (come da dichiarazione del 4
giugno 1895 del medico di 1° classe Rosati).
Vannutelli, nella citata lettera al Roux, ricordava che “quantunque
non incoraggiato da parenti ed amici, tanto feci e tanto dissi che
ottenni di prender parte alla Seconda Spedizione Bottego. Fui uno
degli ultimi ad offrirmi al capitano Vittorio Bottego, poiché,
essendo occupato a dar gli esami del corso superiore, non avevo
potuto presentarmi. Fortunatamente per me l’appello fatto dal
Ministero per trovare ufficiali di Marina che intendessero partire
per tale spedizione non era stato accolto con troppo entusiasmo, e,
quindi, quantunque giunto ultimo, potei riuscire in ciò che era da
anni il mio ideale, cioè di prender parte ad un viaggio di
esplorazione. Questo ideale mi attraeva, e l’entusiasmo destato in
me dalla lettura dei viaggi mi spingeva sempre più verso quella
sospirata meta”.
Il 12
giugno il Regio Ministero degli Affari Esteri lo metteva a
disposizione della Società Geografica Italiana di Roma, sotto i cui
auspici si stava preparando il viaggio, per tutta la durata della
spedizione. Nel frattempo già dal primo giugno si erano sottoscritti
a Roma nella sede della Società Geografica, alla presenza del
Presidente Giacomo Doria, i patti conclusi fra il capitano Bottego,
comandante della spedizione geografica-commerciale, e gli europei
che vi prendevano parte. Costoro, oltre il Vannutelli, erano il
sottotenente di fanteria Carlo Citerni e lo scienziato Maurizio
Sacchi. Il primo paragrafo del contratto stabiliva che i contraenti
si obbligavano ad un’obbedienza cieca ed assoluta agli ordini di
Bottego e quindi a seguirlo dovunque, qualsiasi fossero le
condizioni nella quale si sarebbe venuta a trovare la spedizione.
Tutti i
firmatari rispettarono questa e le altre dieci condizioni del
documento sino alla conclusione della pericolosa esplorazione, che
costò la vita allo stesso Bottego e al dottor Sacchi.
La lealtà
di Vannutelli verso il suo superiore non venne mai meno, neppure
quando ricevette a Massaua una strana lettera firmata dal capitano
Matteo Grixoni, compagno di Bottego nel 1892-93 al tempo
dell’esplorazione del Giuba e disertore dalla medesima sia per
incompatibilità di vedute e di metodi con il collega sia per
disaccordi economici. In questa lettera, spedita da Roma il 26
luglio 1895, Grixoni allegava il fascicolo in bozza di stampa
intitolato Pro Veritate dove sfogava il proprio odio per
Bottego, raccontando – a modo suo - come si era svolta la prima
spedizione. Il Grixoni, dopo aver scritto di aver messo
personalmente in guardia il Rua, cercava con tale lettera di
convincere il Vannutelli allo stesso modo, pregandolo di non
mostrare a nessuno l’opuscolo, «al più al suo collega Dottor Sacchi
che è interessato, non al Citerni satellite di Bottego, il quale a
dire il vero credo sia stato messo costì solo per fiutare
nascostamente gli altri due: Lei e Sacchi. Questo lo dico con
cognizione di causa. (…) A buon intenditor poche parole».
Naturalmente la sorpresa di Vannutelli fu enorme, ma la sua fede,
come quella del Sacchi, verso Bottego fu superiore a questo grave
tentativo di insubordinazione. Bottego, messo al corrente di ciò,
rispose a questo colpo mancino dando procura a suo cognato, il
capitano Pio Citerni, per una querela di diffamazione contro
Grixoni.
Finalmente da Brava, porto somalo sull’Oceano Indiano, il 12 ottobre
si iniziava l’agognato viaggio che li avrebbe portati in territori
dove l’uomo bianco non aveva ancora messo piede. La carovana, a cui
si era aggiunto l’esploratore Ugo Ferrandi, che si sarebbe stabilito
in novembre a Lugh per edificarvi un emporio commerciale sotto il
protettorato italiano, procedeva tra difficoltà innumerevoli, tra
combattimenti, malattie e diserzioni degli ascari. Nel maggio 1896
scoprivano dall’alto di un colle un vasto specchio d’acqua, che fu
battezzato lago regina Margherita. Invece il 29 giugno vedevano
balenare un riflesso argenteo fra gli alberi: era l’Omo. Si misero
subito a seguire il fiume fino alla sua defluenza nel lago Rodolfo
(oggi Turkana). Ormai non avevano più dubbi: l’Omo si getta nel
Rodolfo, il cui bacino non ha emissari. La parte più importante
della missione si era conclusa con una vittoria, ormai si pensava al
ritorno. Bottego intanto, per ragioni di sicurezza, aveva diviso in
due la spedizione. Sacchi doveva seguire una via diversa. Purtroppo
il 5 febbraio del 1897 fu trucidato dagli abissini nei pressi del
Regina Margherita. Ugual sorte doveva toccare più di un mese dopo,
il 17 marzo, al grosso della spedizione. Ancora una volta gli
abissini attaccavano in forze e uccidevano sul colle Daga Roba, nei
pressi di Ghidami, Bottego e gran parte degli uomini di scorta.
Vannutelli e Citerni iniziavano così drammaticamente i loro giorni
di prigionia, che complessivamente sarebbero stati novantotto,
trascorsi in catene. Probabilmente si salvarono perché ritenuti dei
medici. Nella loro nuova professione fecero miracoli, finché non
vennero condotti ad Addis Abeba, al cospetto del Leone di Giuda,
il re dei re Menelik II.
Nella
capitale etiopica, era il 22 giugno, finalmente liberi si
incontrarono con il plenipotenziario italiano, maggiore Cesare
Nerazzini, che aveva l’incarico di ricondurli in patria. I due
superstiti avrebbero voluto fossero liberati anche gli ascari
rimasti prigionieri del degiacc Giotè, tre dei quali erano
stati evirati per essere “schiavi delle sue mogli”; inoltre temevano
che i diari e il materiale scientifico raccolto dalla spedizione
andasse perso. Vannutelli e Citerni desideravano restare in loco per
risolvere queste questioni, ma gli ordini perentori provenienti
dall’Italia li costrinsero a partire. Loro, militari, non potevano
trasgredire.
Per
fortuna i risultati dell’eroico ed importante viaggio non svanirono
nel nulla. Infatti nel dicembre dello stesso anno la Società
Geografica ricevette dal Negus Menelik tre casse contenenti
documenti e collezioni di grande interesse, tra cui quasi tutti i
taccuini di Bottego (in particolare mancava l’ultimo). Con l’aiuto
di questi diari, di quelli di Sacchi, dei loro personali appunti e
naturalmente dei ricordi indelebilmente scolpiti nella memoria,
Vannutelli e Citerni fecero dare alle stampe il resoconto completo
del viaggio di esplorazione. Il voluminoso libro, edito nel 1899 da
Ulrico Hoepli, si intitolava L’Omo – viaggio di esplorazione
nell’Africa Orientale.
In questo
periodo Vannutelli aveva continuato ad interessarsi della sorte
degli ascari, che in seguito furono messi in libertà.
Nel settembre 1897 fu promosso tenente di vascello, “un anno dopo
dei miei compagni di studii, poiché, al tempo della loro promozione,
fui creduto morto; e, conseguentemente, perdetti tutti i vantaggi
relativi agli anni di anzianità nel grado derivanti da tale ritardo,
senza lamentarmene”.
Al termine del 1899 si imbarcò sull’Elba e rimase in
Cina un paio di anni, facendo molte escursioni.
Nel 1903 si sposò con Elisa Carra, “la quale, invece di
ostacolarmi nei miei propositi, mi fu d’incitamento e di aiuto”.
Nel 1904
e nel 1906 il Vannutelli tornava a disposizione della Società
Geografica per due missioni nell’Asia Minore, che descrisse in
articoli nelle pagine del Bollettino della Società
geografica Italiana e in volumi sempre da questa editi: In
Anatolia, aprile-agosto 1904. I Vilajet settentrionali
del 1905 e Anatolia meridionale e Mesopotamia del 1911.
Successivamente abbandonava l’interesse in prima persona per le
esplorazioni, per dedicarsi a combattere con valore nella guerra
italo-turca del 1911 e nella prima guerra mondiale. Decorato di
medaglia d’argento per il suo comportamento durante la spedizione
Bottego ed in particolare per lo scontro del marzo 1897,
brillantemente raggiungeva i vertici della carriera militare.
Infatti veniva collocato a riposo per limiti di età dopo aver
ottenuto il grado di Ammiraglio di Divisione.
Aveva una figlia che nel 1945 fu fucilata dai francesi in Corsica.
Questo tragico evento ebbe molte ripercussioni nella sua vecchiaia
quando, rimasto vedovo, si trovò in salute ma del tutto solo ad
attendere il grande passo1.
Nel 1960
la città di Parma lo invitava per i festeggiamenti del Centenario
della nascita di Bottego, che si svolsero sotto l’alto patronato del
Presidente della Repubblica (le solenni cerimonie furono in buona
parte organizzate dall’allora maggiore Silvio Campioni, autore della
biografia I Giam Giam. Sulle orme di Vittorio Bottego, Parma,
Casa Editrice Luigi Battei). Impossibilitato ad intervenire spedì la
seguente lettera del 6 luglio al presidente del comitato per le
onoranze, generale Bernardo Valentino Vecchi (fondatore nel 1946 a
Milano de Il Gruppo Vittorio Bottego): «Ho gradito molto la
cortese lettera, e sono ben lieto di partecipare di tutto cuore al
vostro Comitato. E’ un onore per me l’invito del Sindaco della cara
Parma di cui conservo sempre migliore memoria. Purtroppo però debbo
farvi considerare che ho novant’anni e perciò mio malgrado non posso
muovermi da Roma. Per me sarebbe stato un immenso piacere rivedere
la vostra città. Però non posso fare altro che inviarvi i miei
migliori auguri con la speranza di avere il piacere di vedervi qui a
Roma».
Lo andò a
trovare la RAI che lo intervistò in occasione di un documentario,
trasmesso il 21 luglio 1960, interamente dedicato al suo antico
comandante. La commossa voce di Vannutelli ricordava ai
telespettatori gli anni della sua avventurosa giovinezza in terra
d’Africa ed il tragico epilogo sul Daga Roba.
La sua
forte fibra si spegneva a Roma il 5 aprile 1966.
Bibliografia:
Franco
Bandini, Vidi Bottego cadere colpito da una pallottola, in
Tempo, n. 17, 27 aprile 1963, Milano, Aldo Palazzi Editore, pp.
48-49;
Manlio
Bonati, Vittorio Bottego, un ambizioso eroe in Africa, Parma,
Silva Editore, 1997;
Manlio
Bonati, Vittorio Bottego. Ricordi e lettere, in Aurea
Parma, Parma, SEGEA, gennaio-aprile 1999, pp. 91-130.
Manlio Bonati,
Vittorio Bottego. Coraggio e determinazione in Africa Orientale,
Torino, Il Tucano Edizioni, 2004;
Silvio
Campioni, I Giam Giam. Sulle orme di Vittorio Bottego, Parma,
Casa Editrice Luigi Battei, 1960;
Rinaldo
De Benedetti, Vittorio Bottego e l’esplorazione del Giuba,
Torino, Paravia, 1931;
Rinaldo
De Benedetti, Vittorio Bottego e l’esplorazione dell’Omo,
Torino, Paravia, 1933;
Paolo
Giudici, Maurizio Sacchi e la 2a Spedizione Bottego,
Pavia, Mario Ambaglio, 1935;
Aroldo
Lavagetto, La vita eroica del capitano Bottego (1893-1897),
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1934;
Onorato
Roux, Infanzia e giovinezza di illustri italiani contemporanei.
Memorie autobiografiche, volume III – Scienziati, Firenze, R.
Bemporad & Figlio, 1910;
Renato Trevis, Sulle orme della seconda spedizione
Bottego, in Rivista delle Colonie Italiane, n. 6,
Sindacato Italiano Arti Grafiche, Roma, giugno 1931, pp. 425-441;
Giorgio
Torelli, Alla ventura col capitano Bottego, Parma, Monte
Università Parma Editore, 2003;
Angelo Umiltà, Gli Italiani
in Africa. Con appendici monografiche su esploratori e personaggi
che calcarono il suolo africano dal 1800 al 1943, a cura di
Giorgio Barani e Manlio Bonati, Reggio Emilia, T&M Associati
Editore, 2004,
Lamberto Vannutelli e Carlo Citerni, La seconda
spedizione Bottego nell’Africa Orientale, in Memorie della
Società Geografica Italiana, volume VIII, parte II, Roma, 1898,
pp. 199-223;
Lamberto Vannutelli e Carlo Citerni, L’Omo. Seconda
spedizione Bottego. Viaggio d’esplorazione nell’Africa Orientale,
Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1899. Una seconda edizione, molto
ridotta e ricca di grossolani errori, è stata ristampata con nuovo
titolo nel 1987: Esploratori. Alla ricerca delle sorgenti del
fiume Omo (1895), Milano, Sugarco Edizioni. In questa sede
Vannutelli si chiama Luigi e la ricerca della defluenza
dell’Omo si tramuta in quella delle sue sorgenti!
Lamberto Vannutelli, Intorno all’ultima spedizione
Bottego. Conferenza del tenente di Vascello L. V., in Atti
del Terzo Congresso Geografico Italiano tenuto in Firenze dal 12 al
17 aprile 1898, volume primo, Firenze, Tipografia di M. Ricci,
1899, pp. 221-236.
1
Dopo la morte dell’amata consorte, avvenuta nel 1950, le
dedicò una biografia intitolata L’enigma di Elisina Carra
e la sua vita intima (1875-1950), pubblicata in un
numero limitato di copie a Roma nel 1951 dalla Tipografia
Ferri. Ormai in pensione, nel 1959 diede alle stampe (sempre
in tiratura limitata), ancora per i tipi della Ferri, le sue
memorie militari: Sguardo retrospettivo sulla mia vita
nella Marina.
|